Le Nazioni Unite approvano un trattato storico per proteggere il mare – #682
Dopo dieci anni di negoziazioni le Nazioni Unite hanno finalmente raggiunto un accordo sul trattato per la protezione degli oceani. Parliamo anche, di nuovo, della siccità e delle sue cause e conseguenze e delle proteste in Israele contro la riforma della giustizia.
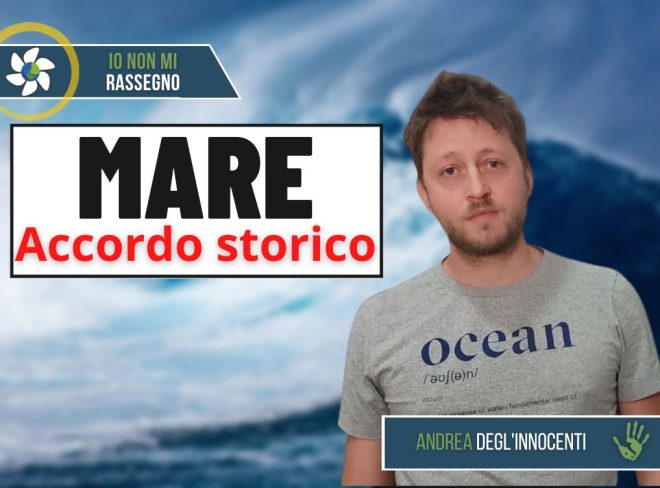
Questo episodio é disponibile anche su Youtube
Sabato sera c’è stato un evento storico. Dopo oltre dieci anni di negoziazioni gli stati membri dell’ONU hanno trovato un accordo internazionale per la protezione degli oceani. Un accordo fondamentale per proteggere gli oceani dalla pesca eccessiva, dal traffico navale, dall’inquinamento, dall’invasione di plastica e così via.
L’obiettivo dell’accordo, spiega il Post, “è che il 30 per cento delle acque internazionali in mare aperto – quelle cioè in cui tutti i paesi hanno diritto a pescare, navigare e fare ricerche – diventino aree protette entro il 2030”.
Si punta a “tutelare e favorire il risanamento delle specie marine a rischio attraverso una serie di politiche e iniziative. In particolare, prevede che nelle aree protette stabilite dal nuovo accordo vengano fissati limiti alla pesca, alle zone in cui possono transitare le navi e alle attività di esplorazione che vi si possono svolgere, come l’estrazione dei minerali dai fondali oceanici. Prevede anche l’istituzione di una conferenza (COP) che si riunirà periodicamente per discutere delle questioni pertinenti”. Ma sì, perché no, una cop in più o in meno.
Le negoziazioni per il nuovo trattato erano cominciate il 20 febbraio e sono durate due settimane, dopo che le ultime si erano concluse lo scorso agosto senza alcun risultato. L’accordo è stato raggiunto soprattutto grazie alla mediazione di Unione europea, Stati Uniti, Regno Unito e Cina, che si sono impegnate per trovare compromessi con i paesi che nel tempo avevano sollevato dubbi sia per quanto riguardava i diritti di pesca che su come ottenere i fondi necessari per implementare le proposte.
Uno dei principali punti di discussione riguardava lo sfruttamento del materiale genetico di piante e animali marini che vivono in mare aperto, che può essere utile per la produzione di farmaci e cibo, ma anche per alcuni processi industriali. Mentre i paesi più ricchi hanno le risorse per esplorare le acque oceaniche e i fondali marini anche per questi scopi, quelli con le economie più deboli no: alcuni chiedevano pertanto rassicurazioni sul fatto che tutti potessero beneficiare in maniera equa degli accordi.
I paesi aderenti dovranno comunque riunirsi di nuovo per adottare formalmente il testo e decidere le modalità per implementarlo. Intanto, l’Unione europea si è impegnata a investire 40 milioni di euro affinché l’accordo venga ratificato e applicato dai paesi aderenti in tempi brevi”.
Il più recente accordo internazionale relativo alla protezione degli oceani e ad altri temi collegati era la Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, che risale al 1982, più di quarant’anni fa. Il nuovo trattato servirà anche per rispettare gli obiettivi dell’accordo raggiunto lo scorso dicembre alla COP15 sulla biodiversità, secondo cui entro il 2030 dovrà diventare protetto il 30 per cento di tutte le aree terrestri e marine (oggi sono il 17 per cento di quelle terrestri e il 10 per cento di quelle marine).
Ora, come sempre in questi casi bisogna stare attenti a non farsi prendere né da entusiasmi eccessivi (del tipo, ok, tutto apposto, abbiamo risolto tutto, non dobbiamo preoccuparci più di niente) né da altrettanto eccessivi disfattismi (del tipo tanto è inutile, non è sufficiente, non cambia niente). È un passaggio storico e importante, al tempo stesso dobbiamo sapere che non è sufficiente, e che serve l’impegno di tutti gli attori della società per tutelar ei mari e gli oceani perché la situazione di questi ecosistemi è vicina a diversi punti critici di non ritorno, al tempo stesso. Insomma, siamo al “pessimismo della ragione – ottimismo della volontà” o giù di lì.
Torniamo a parlare di siccità. Ancora il Post racconta di un nuovo studio che sembra aver trovato un legame abbastanza solido fra il cambiamento climatico e la siccità che da più di un anno sta colpendo il Nord Italia oltre che la Francia, la Svizzera e altre regioni europee, causando molti problemi sia al settore agricolo che a quello della produzione di energia. Che scoperta, direte voi. È da diversi decenni che sappiamo che uno dei tanti effetti devastanti della crisi climatica è l’aumento della siccità.
Vero. Ma un conto è parlare di stime, di medie, di statistiche, un conto è stabilire il legame fra un singolo episodio al tema del cambiamento climatico. Per fare questo vengono realizzati degli studi appositi, e c’è persino un filone di ricerca che si chiama attribution science letteralmente “scienza dell’attribuzione” che è una branca della climatologia sviluppatasi a partire dal 2004 che indaga i rapporti tra il cambiamento climatico ed eventi meteorologici specifici, sviluppando metodi per trovare eventuali collegamenti.
“Semplificando i risultati dello studio – scrive il Post – è emerso che siccità analoghe a quella di questi mesi erano meno estese geograficamente e meno lunghe: il riscaldamento globale sembra aver ampliato le zone di alta pressione e causato una maggiore evaporazione dell’acqua dal suolo e dalle piante.
Più avanti l’articolo spiega: «Ciò che serve per poter attribuire la causa al cambiamento climatico è un meccanismo fisico che leghi i due fenomeni», continua Faranda (che sarebbe uno dei tre ricercatori, due di un istituto di ricerca francese e uno italiano, che vi hanno lavorato): «In questo caso è quello che per semplificare abbiamo chiamato “effetto mongolfiera”: con le emissioni di gas serra facciamo aumentare la temperatura dell’atmosfera e, dato che nei gas la temperatura è legata alla pressione in maniera proporzionale, se aumentiamo la temperatura aumentiamo anche la pressione, proprio come succede nel pallone di una mongolfiera».
«Abbiamo deciso di analizzare questa siccità per due ragioni», spiega Faranda: «Prima di tutto per la sua grande estensione geografica, dato che in passato eravamo abituati a siccità che interessavano solo l’Italia, o parte d’Italia, oppure la Francia e l’Inghilterra, oppure la penisola iberica. Poi perché per l’IPCC [il Gruppo intergovernativo sul cambiamento climatico dell’ONU] c’è una mancanza di studi sulle cause delle siccità nell’Europa occidentale».
La siccità in corso è una siccità idrologica, a cui cioè è associata una riduzione delle acque presenti nei corsi d’acqua, nei laghi e nelle falde sotterranee, e al tempo stesso una siccità agricola, che ha cioè ripercussioni sulle coltivazioni. Non è dovuta solo a una carenza di precipitazioni molto estesa nel tempo, ma anche a temperature più alte della norma che, in associazione al prolungato bel tempo, hanno portato a un aumento della quantità d’acqua che evapora dal terreno e traspira dalle piante (evapotraspirazione). Dunque per analizzarla non basta tener conto unicamente di un’analisi delle precipitazioni, ma anche della temperatura e della risposta del suolo alla mancanza di pioggia”.
L’articolo è molto lungo, qui vi ho letto e commentato solo un pezzetto, e fa parte immagino di un filone di approfondimento con cui il Post sta cercando si affrontare il tema della siccità in maniera abbastanza originale (vi ricordate anche l’articolo sul piano laghetti).
Sempre sulla siccità, ci spostiamo sul Fatto Quotidiano dove Luisiana Gaita racconta di come il nostro Paese si stia attrezzando per affrontarla (più o meno).
Una cabina di regia fra i ministeri coinvolti che definisca un piano di sicurezza idrica, un commissario straordinario che gestisca l’emergenza siccità e metta in pratica il piano del governo, sbloccando interventi ostacolati dalla burocrazia e una campagna che sensibilizzi l’opinione pubblica sull’uso responsabile dell’acqua. A far partire il tutto dovrebbe essere un decreto legge da approvare prima possibile, ma al primo Tavolo sulla sicurezza idrica che si è svolto a Palazzo Chigi non è stata decisa una data. E neppure i conti delle risorse a disposizione tornano, anche se il ministero delle Infrastrutture si è già detto disposto a dare “un contributo significato per la gestione del dossier, anche con l’assunzione di responsabilità dirette”. La cabina di regia è un buon inizio, tra gli altri, per Confagricoltura e Anbi, ma per la Fai-Cisl senza parti sociali rischia di rimanere “una scatola vuota”, mentre Copagri chiede di coinvolgere i settori produttivi.
La critica più dura dal co-portavoce nazionale di Europa Verde e deputato di Alleanza Verdi e Sinistra, Angelo Bonelli: “La cabina di regia convocata dalla presidente Meloni con un esercito di ministri ha partorito il nulla”, se non l’intenzione “di nominare un commissario straordinario tra i tanti commissari di cui già l’Italia dispone”. Il tempo rema contro. E mentre in Italia si apre un dossier, in Francia (dopo oltre 30 giorni senza piogge in pieno inverno) il ministro per la Transizione ecologica Christophe Béchu ha già chiesto ai prefetti di emanare ordinanze di restrizione idrica per anticipare possibili situazioni di crisi durante l’estate. Anche in Catalogna (Spagna) vengono presi i primi provvedimenti. In Italia, per passare dalle parole ai fatti servono investimenti. Lo ricorda la Società italiana di medicina ambientale (Sima): l’Italia investe oggi sulla rete idrica oltre il 50% in meno rispetto alla media europea, perché se i paesi Ue destinano alla manutenzione e depurazione delle acque, in media circa 100 euro a cittadino, in Italia si scende a circa 48 euro ad abitante.
Secondo la Sima per colmare il gap degli investimenti sul ‘Sistema Acqua’ servirebbero in Italia 12 miliardi di euro entro il 2030, oltre a 6 miliardi all’anno solo per la depurazione e la manutenzione della rete idrica. “Numeri che – spiega a ilfattoquotidiano.it il presidente Alessandro Miani – si scontrano con i fondi previsti dal Pnrr”. E di numeri si è parlato anche al Tavolo sulla sicurezza idrica, al quale hanno partecipato anche i ministri Pichetto Fratin (Ambiente), Matteo Salvini (Infrastrutture), Francesco Lollobrigida (Agricoltura), Raffaele Fitto (Pnrr), Roberto Calderoli (Affari regionali), Nello Musumeci (Protezione civile). Proprio quest’ultimo ha ricordato nei giorni scorsi che nel Pnrr ci sono oltre 4 miliardi per il sistema acqua, compresi gli 880 milioni di euro per il potenziamento e l’ammodernamento del sistema irriguo nel settore agricolo, 2 miliardi per nuove infrastrutture idriche primarie (come gli invasi) e 900 milioni per riparare, digitalizzare e monitorare le reti idriche (con progetti che partiranno non prima del 2026).
Infine, prima di chiudere il tema siccità, vi segnalo su GreenMe un articolo di Rosita Cipolla che parla della relazione fra un insetto parassita che sta distruggendo intere porzioni di abeti e altri alberi dell’arco alpino e proprio la siccità.
“Sono rimasti in piedi per decenni, simbolo di forza e bellezza. Poi nell’ottobre del 2018 la furia spaventosa della tempesta Vaia li ha distrutti, lasciando a terra centinaia di migliaia di tronchi. A distanza di 5 anni da quell’evento distruttivo, per gli alberi dell’arco alpino non c’è pace. Nei boschi del Trentino Alto-Adige, del Veneto e del Friuli Venezia-Giulia si aggira una minaccia molto grande (nonostante le sue ridotte dimensioni): il Bostrico Tipografico.
Era stata proprio la forte tempesta mediterranea a creare le condizioni ideali per la proliferazione di questo pericoloso coleottoro; adesso, però, a dare il colpo di grazia ci sta pensando la siccità. L’insetto, infatti, ama il clima arido ed asciutto ed è ingrado di provocare la morte degli alberi già indeboliti dalla compromissione degli habitat.
Il bostrico si infila sotto la corteccia, scavando intricate gallerie che interrompono il flusso della linfa. Tra le sue specie predilette rientrano l’abete rosso, il larice, l’abete bianco e il pino silvestre. All’insetto bastano poche settimane per uccidere un albero.
L’articolo poi parla di una serie di richieste avanzate da Coldiretti a vari Ministri per provare a fermare questa minaccia. Ma qui mi interessava soprattutto cogliere l’occasione per mostrarvi ancora una volta come siccità non significa solo meno acqua per irrigare, ad esempio, ma una serie praticamente infinita di modifiche agli ecosistemi di cui non abbiamo – e non possiamo avere – la più pallida idea delle conseguenze.
Chiudiamo la puntata con una segnalazione. Riporta L’Indipendente che “Decine di migliaia di israeliani hanno nuovamente manifestato nella giornata di sabato contro il piano del primo ministro Benjamin Netanyahu di riforma del sistema giudiziario. Le proteste sono motivate dal timore che le modifiche possano indebolire la Corte Suprema, limitare il potere dei giudici e minacciare le istituzioni democratiche. Nel corso della manifestazione a Tel Aviv sono comparse bandiere israeliane e immagini che ritraevano Netanyahu come un dittatore, ma anche bandiere palestinesi”.
#mare
il Post – C’è un nuovo trattato internazionale per la protezione degli oceani
Rinnovabili.it – Il tipping point del carbonio negli oceani
#siccità
il Post – La siccità nel Nord Italia sembra legata al cambiamento climatico
il Fatto Quotidiano – Sos siccità: Francia e Spagna prendono provvedimenti, l’Italia apre un “tavolo”, ma non affronta il problema degli investimenti. E spende il 50% in meno della media Ue
#bostrico
GreenMe – È allarme insetti killer nei boschi delle Alpi: la siccità sta causando (anche) una strage di alberi
#Israele
L’Indipendente – Israele, migliaia in piazza contro la riforma della giustizia
#Ucraina
il Post – Dal G20 arriva la conferma che sull’Ucraina il dialogo è lontano
#Cina
il Post – Il parlamento in Cina confermerà ancora il potere di Xi Jinping
#diritti
il Post – La Francia vuole garantire ai minori il diritto alla loro immagine online
#esplosioni
GreenMe – Gigantesca esplosione di un deposito di carburanti a Giacarta, almeno 17 morti
#Colombia
il Post – In Colombia 79 poliziotti sono stati presi in ostaggio e poi liberati dai manifestanti
Segnala una notizia
Segnalaci una notizia interessante per Io non mi rassegno.
Valuteremo il suo inserimento all'interno di un prossimo episodio.








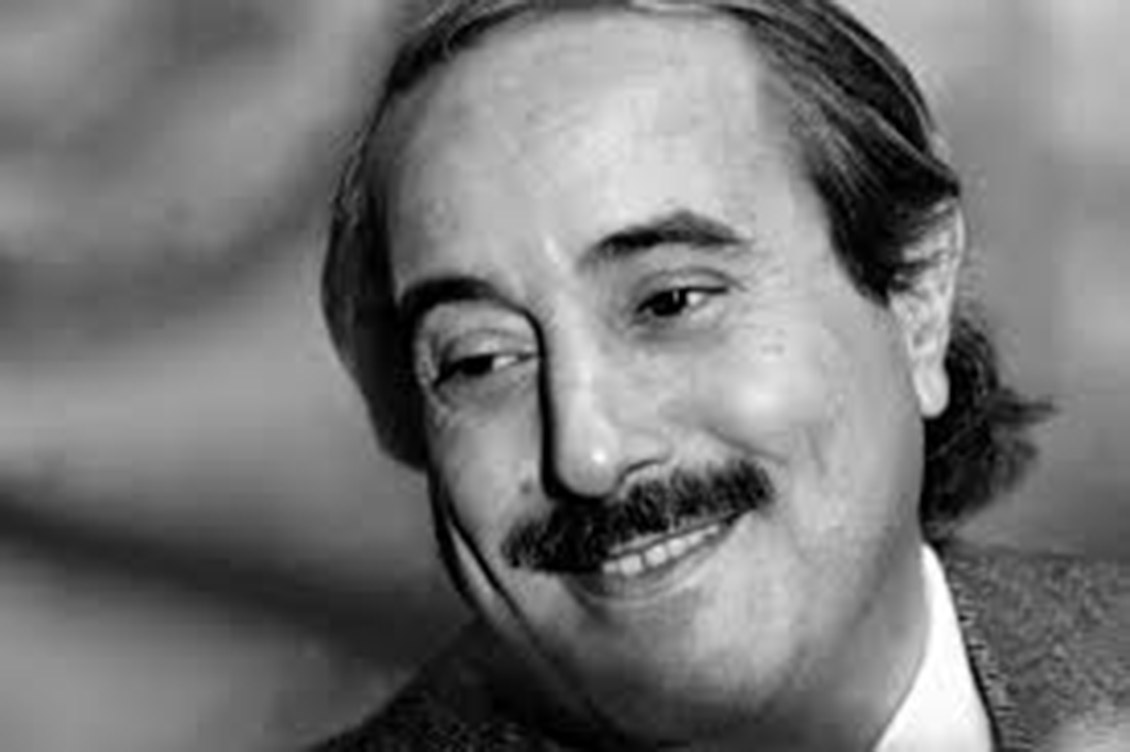





Commenta l'articolo
Per commentare gli articoli registrati a Italia che Cambia oppure accedi
RegistratiSei già registrato?
Accedi