Il reato di rivolta in carcere nel nuovo decreto sicurezza è un problema – 17/4/2025
Parliamo di carcere, PFAS, media e clima, indigeni e città più pulite e sostenibili. Tra buone notizie e derive preoccupanti, ecco cosa sta succedendo.

Questo episodio é disponibile anche su Youtube
Fonti
#carceri
il Post – I problemi del reato di “rivolta in carcere” introdotto dal governo
#PFAS
L’Indipendente – PFAS, qualcosa si muove: l’Unione Europea li limita a cominciare dai giocattoli
#India
Italia che Cambia – Fatti a pezzi: India pronta a sacrificare una delle tribù più isolate del mondo per creare la sua ‘nuova Hong Kong’
Survival International – CRUSHED How India plans to sacrifice one of the world’s most isolated tribes to create “the new Hong Kong”
#Parigi
GreenMe – Parigi dice addio alle auto. Le mappe dell’inquinamento atmosferico rivelano un cambiamento radicale
#informazione
Italia che Cambia – Media italiani e clima: dimezzate le notizie, avanzano le voci contro la transizione energetica
#tram
Italia che Cambia – Il tram torna protagonista nelle città italiane
Trascrizione episodio:
Credo che più o meno l’80-90% degli articoli di giornale sulle carceri contenga la famosissima citazione di Voltaire che dice «Il grado di civiltà di un Paese si misura osservando la condizione delle sue carceri». Compresi quelli scritti da me. Perché è una di quelle robe in cui, credo, sentiamo sia presente una profonda verità. la capacità di passare da uno stato punitivo, a uno stato invece davvero liberale, in cui il carcere è un modo per allontanare temporaneamente dalla società qualcuno che potrebbe essere pericoloso, ma al tempo stesso dargli gli strumenti per fare una vota migliore.
Tutto questo preludio per andare a parlare di un aspetto del Decreto sicurezza da poco approvato che non abbiamo troppo approfondito, quello dell’inasprimento delle pene per le proteste nelle carceri.
Lo facciamo oggi approfittando di un pezzo del Post. In pratica, come forse ricorderete, dentro il decreto ci sono diverse misure su ordine pubblico, polizia, carcere e sicurezza in generale. Ma una, in particolare, sta sollevando un coro di critiche: è il nuovo reato di “rivolta in carcere”, previsto dall’articolo 415-bis del codice penale, che introduce pene da uno a cinque anni per i detenuti che partecipano a “atti di violenza o minaccia o resistenza” agli ordini, anche passivamente, se compiuti da almeno tre persone.
Anche la resistenza passiva. Che è un problrema. Nel senso che è una formulazione talmente vaga che secondo molti esperti penalisti lascia spazio a interpretazioni pericolose. Tipo, potrebbero essere puniti:
Scioperi della fame, utilizzati dai detenuti come forma di protesta.
Battitura delle sbarre o altri rumori coordinati per esprimere dissenso.
Sedersi o sdraiarsi a terra rifiutando di muoversi quando richiesto.
Insomma tutte quelle forme anche pacifiche di protesta che nelle carceri possono fare la differenza fra subire o meno violenze. La norma è tanto ambigua che il presidente della Repubblica Mattarella aveva chiesto chiarimenti prima della firma, chiarimenti che non sono mai arrivati.
Anche in questo caso la norma arriva come risposta a dei fatti di cronaca – un modus operandi che abbiamo osservato spesso in questo governo. Il nuovo articolo è stato pensato come risposta alle proteste nelle carceri italiane, sempre più frequenti e diffuse. Solo nel 2024 ci sono stati circa 1.500 episodi di protesta collettiva non violenta: battiture, rifiuti di rientrare in cella, scioperi della fame. Ma ora, con questa norma, anche queste forme di dissenso potrebbero diventare perseguibili penalmente.
E non solo: il reato si applicherà anche nei CPR, i Centri di Permanenza per il Rimpatrio, dove le condizioni sono già gravemente compromesse e le proteste frequenti. Qui, il rischio di criminalizzare la disperazione di chi protesta per la mancanza di diritti fondamentali è altissimo.
Martedì, dopo una rivolta nel carcere di Piacenza, il sindacato Uspp ha subito invocato l’applicazione del nuovo reato.
Nel frattempo le tensioni aumentano. Nei pochi giorni successivi all’entrata in vigore del decreto si sono già verificati due episodi di disordine a Cassino e Piacenza. Secondo il sindacato Uilpa, la repressione da sola non funziona, e anzi rischia di aggravare un’emergenza carceraria che resta irrisolta: sovraffollamento, mancanza di personale, condizioni di vita disumane.
Intanto anche l’ONU è intervenuta: i relatori speciali delle Nazioni Unite hanno scritto al governo italiano chiedendo di abrogare il decreto, definendo la norma sulla rivolta una “restrizione sproporzionata del diritto di protesta pacifica e di espressione”.
Resta il nodo fondamentale: punire ancora più duramente chi protesta non risolve i problemi strutturali delle carceri italiane. Li nasconde. E peggiora la situazione.
C’è una piccola buona notizia sul fronte della regolamentazione dei PFAS che arriva dall’Ue.
I PFAS – sostanze per- e polifluoroalchiliche – sono composti chimici ultra-resistenti usati per rendere impermeabili, antigrasso o ignifughi vari prodotti di uso quotidiano: dai tessuti alle padelle antiaderenti, fino ai cosmetici. Il problema è che non si degradano mai. Per questo vengono anche chiamati “inquinanti eterni”. E le conseguenze per la salute sono pesanti: tumori, disturbi endocrini, problemi immunitari, malformazioni fetali. E sono ovunque. Anche nell’acqua potabile.
Ma, come scrive Simone Valeri su L’Indipendente, dopo anni di stallo e pressioni delle lobby, l’Unione Europea sembra finalmente pronta ad approvare nuove regole per mettere al bando le sostanze tossiche dai giocattoli. Un accordo politico tra Parlamento e Consiglio UE, basato su una proposta della Commissione, prevede il divieto di PFAS, interferenti endocrini, bisfenoli e altre sostanze pericolose nei giocattoli prodotti o importati nell’Unione.
In pratica la normativa – che ora attende l’approvazione formale – prevede l’introduzione di un passaporto digitale dei prodotti, per impedire l’ingresso sul mercato (anche online) di giocattoli non sicuri.
Da tempo le associazioni ambientaliste chiedono una messa al bando totale dei PFAS in tutti i settori. Per ora però, l’unico divieto concreto riguarda i giocattoli. La Francia è stata la prima a spingersi oltre, vietando i PFAS nei tessuti e nei cosmetici e introducendo una tassa sugli scarichi industriali.
Perché l’UE si muove così lentamente? Una risposta arriva dall’inchiesta giornalistica “Forever Lobbying Project”, che ha raccolto oltre 14.000 documenti mostrando come le lobby dell’industria chimica abbiano esercitato pressioni sistematiche sui decisori politici, portando avanti campagne di disinformazione per minimizzare i rischi dei PFAS e rallentare ogni tentativo di divieto.
È l’ennesimo caso in cui salute pubblica e interessi economici si scontrano. E la domanda è sempre la stessa: quanto ancora dovremo aspettare prima che il diritto alla salute venga davvero prima del profitto?
Media e clima hanno avuto sempre un rapporto problematico, che sembrava essere migliorato negli anni ma poi è tornato a peggiorare. Nel 2024, l’attenzione dei media italiani sulla crisi climatica è calata drasticamente. A dirlo è un nuovo studio dell’Osservatorio di Pavia per Greenpeace: rispetto al 2023, le notizie sui cambiamenti climatici sono diminuite del 47% sui quotidiani e del 45% nei telegiornali. E mentre cala la copertura giornalistica, aumentano le pubblicità di aziende inquinanti, soprattutto dei settori gas, petrolio e automotive.
Le poche notizie che passano si concentrano più sui costi economici delle politiche climatiche che sugli impatti ambientali. Crescono anche i contenuti contrari alla transizione ecologica (17% sui giornali, 19% nei TG), con i politici – soprattutto membri del governo – a dominare il dibattito, spesso per criticare le politiche UE, spingere per il nucleare e opporsi a normative come la direttiva Case Green.
Il rischio, denuncia Greenpeace, è che questa dinamica generi un effetto di autocensura nei media e rallenti la pressione pubblica per politiche climatiche urgenti. Si crea così un vuoto informativo che ostacola la transizione ecologica proprio nel momento in cui dovrebbe accelerare.
Una tendenza che sembra andare a braccetto con quello che il magazine Valori ha definito – in ambito aziendale – “postwashing”: ovvero una fase in cui dopo anni di slogan e marketing verde, molte aziende nemmeno fingono più interesse per l’ambiente. Insomma, in un contesto globale segnato da crisi, guerre e instabilità, la narrazione dominante torna a essere quella del business as usual, centrata su profitto e fossili.
E questo non incoraggiante. È anche vero che, come ha fatto notare Giovanni Mori in una puntata di Io Non Mi Rassegno +, non tutto questo è per forza negativo: nel senso che forse se ne parla meno perché la transizione è iniziata davvero. E ora non è più tempo solo di annunci, ma di affrontare conflitti, ostacoli, compromessi. Insomma: il dibattito si sposta dal “se” al “come” farla. Non voglio che suoni come una giustificazione per il silenzio dei media, però forse p una fase propedeutica. Almeno spero. Noi nel frattempo, ne parliamo.
C’è un angolo remoto dell’Oceano Indiano, l’isola di Great Nicobar, che rischia di diventare teatro di un’ennesima frattura tra sviluppo economico e diritti delle popolazioni indigene. Il governo indiano ha annunciato un grande progetto infrastrutturale da miliardi di dollari per trasformare l’isola in un nuovo hub strategico ed economico, con la costruzione di un porto, un aeroporto, una centrale elettrica e una nuova città.
Ma c’è un problema, anzi più di uno. Quest’area ospita una delle tribù più isolate e vulnerabili del mondo: gli Shompen, circa 300 persone che vivono da millenni nelle foreste pluviali dell’isola conducendo una vita nomade, basata su caccia e raccolta, in totale simbiosi con l’ambiente circostante.
Secondo Survival International e diverse altre organizzazioni, questo progetto potrebbe segnare la fine per gli Shompen. La loro esistenza sarebbe messa a rischio dalla deforestazione massiccia, dalla perdita dell’habitat e dall’esposizione a malattie esterne contro cui non hanno difese. Il tutto con una procedura che, denunciano le associazioni, è avvenuta senza una reale consultazione delle comunità locali, in violazione delle leggi che dovrebbero proteggerne i diritti.
Il governo indiano, dal canto suo, continua a sostenere che non ci saranno sfollamenti forzati e che verranno adottate misure per minimizzare l’impatto ambientale. Ma intanto, il progetto ha già ottenuto l’approvazione ambientale nel novembre 2022 e potrebbe partire a breve.
La questione è ancora aperta: le pressioni internazionali e le possibili azioni legali potrebbero rallentare o fermare il progetto. Intanto, le voci che chiedono di fermare tutto e ripensare le priorità stanno crescendo.
Buone notizie arrivano da Parigi, dove le politiche ecologiche della sindaca Anne Hidalgo mostrano effetti sempre più notevoli. Nuove rivelazioni della qualità dell’aria nella capitale francese hanno mostrato che tra il 2005 e il 2024, i livelli dei due principali inquinanti atmosferici – il particolato fine (PM2.5) e il biossido di azoto (NO₂) – sono calati rispettivamente del 55% e del 50%.
Insomma complessivamente sono più che dimezzati. Un risultato impressionante.
Ne parla Germana Carillo su GreenMe, che cita l’ultimo report di Airparif, l’agenzia regionale per la qualità dell’aria, che ha tracciato un quadro dettagliato dell’evoluzione dell’inquinamento negli ultimi vent’anni. I dati sono molto chiari e mostrano che l’idea di puntare sulla riduzione del traffico auto privato, il potenziamento del trasporto pubblico, le zone a basse emissioni e l’espansione delle piste ciclabili hanno funzionato.
Se osservate la mappa che nel 2023 mostra in rosso le zone della città in cui si superano i limiti europei di biossido di azoto, vedrete colorate di rosso praticamente solo una rete sottile di strade e autostrade. Nel 2005, invece, tutta la mappa era praticamente rossa.
E questo ovviamente ha effetti sulla salute. Secondo Airparif, il numero di decessi prematuri legati all’inquinamento atmosferico è calato di un terzo tra il 2010 e il 2019. E si stima che almeno un quarto delle morti premature restanti potrebbe essere evitato se si rispettassero i futuri limiti europei.
L’articolo cita anche altri dati, ad esempio il fatto che nel 2024, solo 800 persone nell’Île-de-France – la regione di Parigi – vivono ancora in zone dove i livelli superano i limiti consentiti – ed erano 5.000 solo l’anno prima.
Così come si cita il dato dell’ozono a bassa quota, che invece non è migliorato. L’ozono a bassa quota sarebbe quello che si forma per reazione chimica tra altri inquinanti sotto l’azione della luce solare ed è l’unico tra i grandi inquinanti che non è diminuito a Parigi. Anzi, risente fortemente del riscaldamento globale e del trasporto di inquinanti da altre regioni.
Al netto di questo, la notizia è molto interessante, non solo per chi vive a Parigi e dintorni, ma per chiunque perché mostra come con un apolitica lungimirante e una strategia a lungo termine e continuativa per rendere le città più vivibili e sostenibili poi i risultati si ottengono.
Che poi, in realtà, le nostre città non stanno proprio a guardare. Forse più lentamente e in maniera meno evidente, ma si muovono. Come si muovono? Spesso in tram.
Il tram infatti in Italia sta andando incontro a una vera e propria rinascita, rifioritura. E trasforma le città. Secondo i nuovi dati diffusi da un report di Legambiente presentato pochi giorni fa, sono in fase di realizzazione 250 km di nuove linee tramviarie – ovvero, tenetevi forte, il 63% in più rispetto a quelle oggi in esercizio. Che è tanta roba. Anche l’investimento complessivo è alto, parliamo di circa 5,4 miliardi di euro, in parte finanziati dal PNRR.
Le città capofila di questa “rinascita” sono Bologna, Firenze, Padova, Milano, Roma, ma anche Palermo, Bergamo, Brescia, Napoli, Cagliari e Sassari. Solo Roma, ad esempio, ha in programma quattro nuove linee per un totale di 34,2 km. Tra queste, anche la molto discussa tranvia Termini-Vaticano-Aurelio, che collegherà il cuore del centro storico fino al Vaticano. Molto discussa come tutte le opere che comportano lavori, un’iniziale congestione del traffico, ma che poi quando ci sono diventano anche molto apprezzate. In genere.
E i numeri raccontano un successo crescente anche in termini di utilizzo: a Firenze nel solo 2024 i passeggeri del tram sono aumentati dell’11,8%, superando quota 39 milioni. A Padova, un quarto degli spostamenti su trasporto pubblico locale avviene su rotaia.
Insomma, è una vera rinascita, e il tram piac. E poi ha altri vantaggi: È economico da realizzare, ha un basso impatto ambientale e migliora la qualità della vita urbana.
Il report Legambiente mette anche in guardia dai rischi che sia una promavera molto breve, quella della rinascita dei tram. Perché la Legge di Bilancio 2024 è la prima dal 2017 a non stanziare fondi per il Trasporto Rapido di Massa, tagliando risorse anche per la ciclabilità e la compensazione dei rincari sui materiali. Una scelta che il report definisce paradossale, considerando che il costo complessivo delle nuove tramvie italiane (5,4 miliardi) è un terzo di quanto servirebbe per costruire solo 3 km del Ponte sullo Stretto.
Quindi, ecco, il report sottolinea come si debba continuare con gli investimenti e sia davvero stupido fermarsi adesso, forse non dice proprio stupido, ma il senso è un po’ quello. Però comunque non male.
Segnala una notizia
Segnalaci una notizia interessante per Io non mi rassegno.
Valuteremo il suo inserimento all'interno di un prossimo episodio.








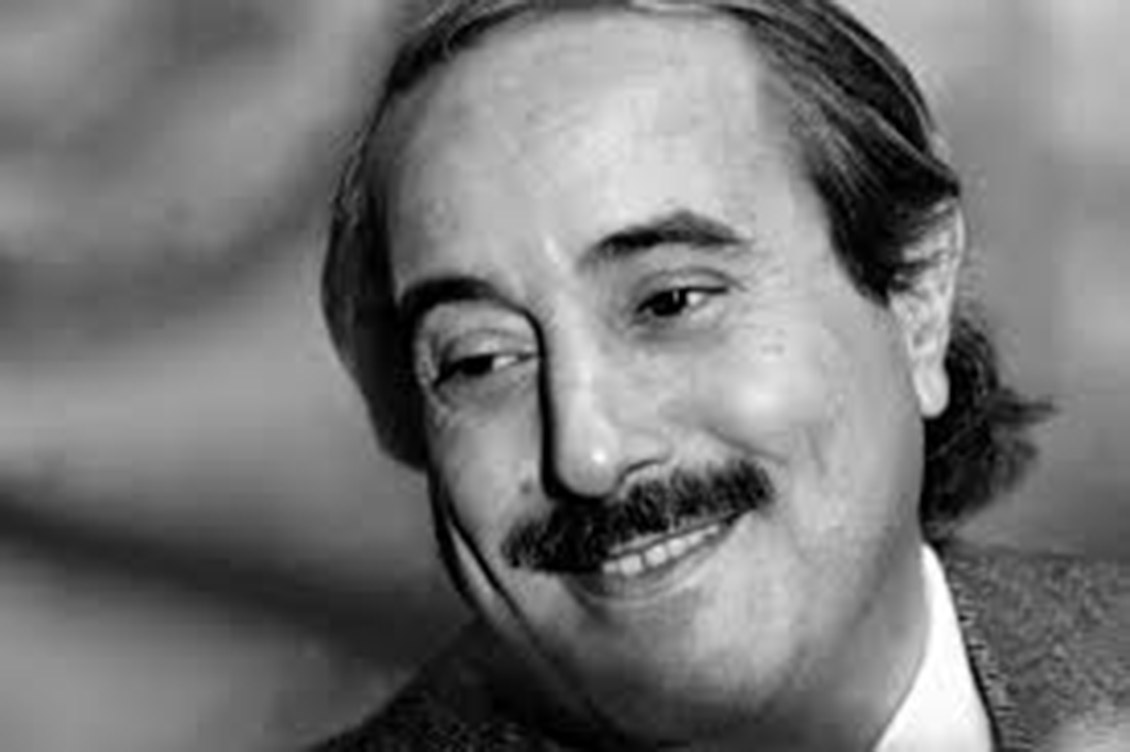





Commenta l'articolo
Per commentare gli articoli registrati a Italia che Cambia oppure accedi
RegistratiSei già registrato?
Accedi