Il piano Mattei, la geopolitica globale: il delicato rapporto fra Italia e paesi africani – 3/4/2025
Italia sempre più attiva in Africa tra sostenibilità e geopolitica, mentre Musk inciampa in Wisconsin. Oslo e l’Europa spingono sulla transizione ecologica.

Questo episodio é disponibile anche su Youtube
Fonti
#Italia-Africa
Panorama – Italia, firmato accordo per l’agricoltura sostenibile con la Repubblica Democratica del Congo
il Sole 24 Ore – I piani concreti delle imprese italiane per l’Africa
Italia che Cambia – Accordo Girolomoni-La Terra e il Cielo: il bio marchigiano insieme per resistere alle distorsioni dei mercati
#Myanmar
L’Indipendente – Birmania, tre gruppi ribelli annunciano il cessate il fuoco unilaterale
L’Indipendente – Birmania, anche la giunta annuncia il cessate il fuoco
#Musk
il Post – L’appoggio di Elon Musk ha danneggiato il giudice Repubblicano Brad Schimel?
Al Jazeera – Wisconsin Supreme Court election results: What happened and why it matters
#CO2
la Repubblica – Clima: in orbita il primo satellite europeo per misurare i flussi di CO2
#comuni virtuosi
Altreconomia – I Comuni virtuosi compiono vent’anni. Portando un’idea sempre nuova di politiche pubbliche
#Oslo
European Commission – Once a green capital, always a green capital: Oslo’s continued path to sustainability
#inquinamento
European Commission – The Zero Pollution Dashboard
Si sta parlando molto di accordi fra il nostro paese e vari paesi africani, in questi giorni. Non troverete notizie sulle prime pagine, come tutte le cose che riguardano il continente africano, però ci sono parecchie cose che bollono in pentola e che si muovono su un crinale un po’ scivoloso, in cui da un lato ci sono aiuti economici che vogliono favorire, almeno a parole, l’agricoltura biologica e la transizione energetica, dall’altro ci sono interessi economici meno chiari, manovre geopolitiche, nuove forme di colonialismo.
Ecco, le operazioni italiane in Africa si muovono un po’ in questo limbo, e fra l’altro fanno parte di giochi ancora più ampi. Ma andiamo con ordine. L’ultima notizia in ordine temporale è che il 31 marzo è stato firmato un accordo tra il governo della Repubblica Democratica del Congo e l’azienda italiana BFI per la creazione di un modello di agricoltura sostenibile su 10.000 ettari nell’area di Dolisie.
Ora, BFI è una controllata di Bonifiche Ferraresi, che è la più grande azienda agricola italiana, un colosso quotato in borsa. Che sembra essere un po’ l’alfiere dell’agricoltura italiana d’esportazione in Africa. Già qualche mese fa il governo le aveva affidato 36mila ettari di terreno in Algeria per la bonifica e la conversione agricola dell’area. Quest’ultimoi progetto nella Repubblica Dominicana è sulla carta ancora più ambizioso perché, leggo da un articolo su Panorama, punta a rafforzare la sicurezza alimentare del Paese e al tempo stesso a generare sviluppo locale, formazione e infrastrutture.
Vediamo meglio cosa prevede l’accordo. Leggo ancora su Panorama, l’articolo è a firma di Franco maisano, che “L’intesa prevede la realizzazione di una “model farm” – quindi una sorta di best practice, una fattoria modello – in grado di integrare le migliori pratiche agricole con il coinvolgimento attivo delle comunità locali. Verranno costruite reti idriche, rinnovate le infrastrutture esistenti e avviati percorsi di formazione per giovani e donne, per rendere il progetto non solo produttivo, ma anche inclusivo. Che dovrebbe diventare una sorta di modello e di biglietto da visita del Piano Mattei.
Il Piano Mattei è questa strategia del governo italiano per rafforzare le relazioni economiche e politiche con i Paesi africani, promuovendo progetti in ambito energetico, agricolo e infrastrutturale, con l’obiettivo dichiarato di creare partenariati paritari per uno sviluppo sostenibile. È un piano su cui il governo Meloni ha puntato molto.
E che adesso inizia a prendere forma. L’accordo con la Repubblica Dominicana è solo l’ultimo di una serie di accordi. Ad esempio c’è il progetto Elmed, la prima interconnessione elettrica a corrente continua tra Italia e Tunisia, con Terna protagonista e fondi europei a supporto.
Si tratta di un grande cavo sottomarino, una di quelle infrastrutture necessarie per la transizione energetica, che dovrebbe servire allo scambio di energia fra Italia e Tunisia. La direzione del flusso elettrico sarà bidirezionale, ma con una particolare enfasi – almeno inizialmente – sull’importazione di energia rinnovabile prodotta in Nord Africa, soprattutto da fonti solare ed eolica, verso l’Europa.
C’è poi il coinvolgimento diretto di imprenditori come Andrea Illy, impegnato in Africa orientale per migliorare la redditività delle coltivazioni di caffè, e di aziende come Sparkle, che sta sviluppando la connettività digitale tra Europa e Africa.
Ma il progetto simbolo della nuova fase è forse il Corridoio di Lobito, che è una grossa infrastruttura ferroviaria – insomma una linea ferroviaria, che collegherà la costa dell’Angola allo Zambia, per facilitare il trasporto delle materie prime critiche dall’africa centrale verso la costa. Un’opera considerata strategica, sostenuta dagli Usa, dall’Ue e anche dal governo italiano con 320 milioni di dollari, che mira a ridurre i tempi di trasporto da 45 giorni a una sola settimana.
Il corridoio è pensato per facilitare in particolare il trasporto di materie prime critiche, fondamentali per la transizione energetica e digitale. Tra cui:
- rame (essenziale per la produzione di cavi e componenti elettrici),
- cobalto (utilizzato nelle batterie ricaricabili),
- litio,
- e altri minerali strategici estratti soprattutto in Congo e Zambia.
E secondo quanto dichiarato dal ministro degli Esteri della Tanzania, si sta anche lavorando a un’estensione del corridoio fino all’Oceano Indiano, trasformando così il progetto in una traversata terrestre dell’Africa che collegherebbe l’Atlantico all’Indo-Pacifico, quindi che taglierebbe a metà il continente. Diventando uno snodo potenzialmente decisivo per ridefinire la geopolitica delle infrastrutture globali.
Fra l’altro l’iniziativa a sua volta rientra nella cornice del Global Gateway europeo e della PGII americana, che sono le due grandi iniziative con cui Ue e Usa vogliono investire in infrastrutture strategiche in Africa, Asia e America Latina, come risposta alle crescenti influenze della Cina con la sua Via della Seta.
Insomma, come vedere ci sono tanti cerchi concentrici. Ci sono i singoli progetti locali, alcuni di essi probabilmente anche interessanti. C’è una cornice che riguarda il nostro paese, che è il Piano Mattei, con cui l’Italia rilancia le sue ambizioni di relazioni con l’Africa, e che fra l’altro è un po’ la versione pratica del’aiutiamoli a casa loro che per anni è stato lo slogan della destra in tema immigrazione. Perché spesso a questi progetti che vengono raccontati e presentati alla stampa si affiancano accordi più o meno espliciti con governi spesso autoritari per bloccare i flussi migratori.
E poi ci sono le cornici ancora più ampie che riguardano le mire di Europa e Usa di sfruttare le risorse africane in termini di transizione ecologica e contrasto geopolitico all’espansione cinese.
Insomma, come al solito la realtà è molto complessa e fatta di tanti strati, che vanno osservati da distanze diverse. Anche qui vediamo, nel grande, quelle logiche un po’ coloniali che possiamo osservare ad esempio in Sardegna. Così come – al tempo stesso, visto che la transizione energetica in qualche modo va fatta – ogni impianto che non faremo da noi sarà probabilmente un impianto che faremo in qualche paese più povero. Non esiste una ricetta perfetta a questa equazione dalle infinite variabili. Ma intanto sapere quello che succede mi sembra un primo passo importante.
Visto che spesso mi chiedete come potete aiutare INMR a crescere, e visto anche che di recente YT ha cambiato i suoi algoritmi, vi do qualche dritta.
Se segui Io non mi rassegno su YouTube puoi:
- Iscriviti al canale, se non l’hai già fatto.
- Lasciare un like e un commento sotto i video: sono segnali che YouTube interpreta come soddisfazione del pubblico.
- Condividi i video con chi pensi possa apprezzarli.
- E se ti va, guarda più di un video: aiuta l’algoritmo a capire che ti interessa davvero.
Se lo ascolti su Spotify o altre piattaforme audio invece puoi:
- Segui il podcast, cliccando su “segui”
- Lascia una valutazione positiva, se la piattaforma lo consente (tipo le stelline su Spotify).
- E soprattutto, spargere la voce: condividere Io non mi rassegno con amici e amiche è sempre il miglior modo per farlo crescere.
Fine del messaggio autopromozionale.
Nel Myanmar devastato da un terremoto che ha già causato oltre 2.700 vittime, arriva una notizia che, almeno per ora, lascia spazio alla speranza o almeno mostra un segnale di umanità: una tregua temporanea tra l’esercito regolare e alcuni dei principali gruppi ribelli. L’iniziativa è stata lanciata per facilitare la risposta umanitaria internazionale e consentire l’ingresso e la distribuzione degli aiuti nelle aree colpite, dopo che nei primi giorni la giunta militare aveva continuato a bombardare i ribelli.
Ad aprire la strada è stata l’Alleanza delle Tre Fratellanze, coalizione composta da tre gruppi armati attivi nel Paese – l’Esercito dell’Alleanza Democratica Nazionale del Myanmar, l’Esercito di Liberazione Nazionale di Ta’ang e l’Esercito di Arakan – che ha annunciato un cessate il fuoco unilaterale della durata di un mese. L’alleanza ha invitato l’esercito birmano a fare lo stesso e, nel giro di 24 ore, anche la giunta militare ha dichiarato un proprio stop temporaneo delle operazioni offensive, valido fino al 22 aprile.
Nonostante questi annunci, la situazione sul terreno resta tesa. Il Karen National Union, altro importante gruppo armato ma non parte dell’Alleanza, ha accusato l’esercito regolare di continuare i bombardamenti in alcune aree, malgrado la gravità della catastrofe naturale. È un promemoria amaro di quanto il conflitto interno al Myanmar, in corso dal colpo di Stato del 2021, sia profondamente radicato e difficile da fermare, anche davanti a una tragedia umanitaria di questa portata.
Resta da vedere se questa tregua parziale e temporanea verrà rispettata da tutte le parti, e soprattutto se sarà sufficiente per consentire un reale afflusso di aiuti nelle zone più colpite dal sisma, molte delle quali sono in mano ai gruppi ribelli o difficilmente raggiungibili.
Martedì scorso si è votato nel Wisconsin per eleggere un giudice della Corte Suprema statale. Una notizia che, di per sé, potrebbe sembrare marginale – una di quelle elezioni locali che raramente escono dai confini dello stato. E invece, pensate, questa è stata la più costosa corsa giudiziaria della storia degli Stati Uniti, diventata in poche settimane un test politico nazionale e internazionale.
Perché? Perché da un lato c’era la candidata liberale Susan Crawford, sostenuta dai Democratici. Dall’altro, il candidato conservatore Brad Schimel, appoggiato dal presidente Trump e – soprattutto – finanziato massicciamente da Elon Musk.
Crawford ha vinto con un vantaggio netto, il 54,4% dei voti, permettendo così ai liberali di mantenere la maggioranza nella Corte (4 a 3). Una vittoria che, come ha dichiarato lei stessa, “ha scongiurato un attacco senza precedenti contro la nostra democrazia”, e che, in effetti, racconta molto di più di un semplice cambio di toghe.
Nel mezzo di questa battaglia c’erano quasi 100 milioni di dollari investiti in campagna elettorale, con Musk che da solo ha messo sul piatto circa 21 milioni, tra fondi diretti e spese delle sue organizzazioni. Ha anche rilanciato le sue bizzarre “lotterie” per gli elettori, in cui prometteva premi in denaro – fino a 1 milione di dollari – a chi partecipava a iniziative pro-Schimel.
Nonostante questo, anzi probabilmente anche a causa di questo – questa è la parte più interessante – Schimel ha perso. Come racconta Aljazeera, i Democratici sono stati abili nel trasformare il voto in un referendum su Musk, accusandolo di voler “comprare” la Corte Suprema dello stato. E pare abbia funzionato. Secondo diversi osservatori, la presenza ingombrante del miliardario ha avuto un effetto controproducente, in particolare sugli elettori indipendenti, che hanno percepito la sua ingerenza come un abuso di potere.
Ma perché Musk era così interessato a questa elezione? Alcuni giornali statunitensi hanno ipotizzato un possibile conflitto d’interessi diretto: a febbraio, Tesla – l’azienda di Musk – ha chiesto al governo del Wisconsin un’esenzione a una legge che vieta ai produttori automobilistici di vendere direttamente ai consumatori. Un eventuale ricorso in tribunale avrebbe potuto finire proprio davanti alla Corte Suprema statale. Un motivo in più per assicurarsi una maggioranza amica.
C’è poi un aspetto più politico. Il Wisconsin è uno stato chiave: uno di quegli “swing states” che decidono le elezioni presidenziali. Trump lo ha vinto di misura nel 2024, ma il governatore è democratico e la distribuzione dei poteri locali è molto equilibrata. In questo contesto, controllare la Corte Suprema può fare la differenza su questioni cruciali come i diritti riproduttivi, il redistricting (cioè il disegno dei collegi elettorali), le leggi elettorali e tanto altro.
Comunque, questa elezione ci mostra come diverse cose interessanti. intanto che i soldi spesi in campagna elettorale sicuramente hanno un peso, ma non possono condizionare del tutto una votazione e a volte possono essere un boomerang.
E poi che tutto è molto transitorio. Ora, non possiamo dire che sia l’inizio della fine per Musk, però la sua popolarità è in picchiata, le sue aziende sono in perdita costante e le cose non stanno girando bene. Questro per dire che nell’era della mememodernità tutto può cambiare in un istante, e questa cosa si può ritorcere contro anche a chi pensa di poter governare i processi.
Ora, l’agenda setting vorrebbe che io parlassi dei dazi di Trump, però immagino che ne sentirete parlare abbondantemente altrove. Quindi sì, Trump ha annunciato un sacco di dazi, sono tutti molto arrabbiati e secondo molti analisti questa cosa gli si ritorcerà contro.
Nel maggio del 2005, 20 anni fa, in un’Italia in cui parlare di sostenibilità non era né mainstream né particolarmente popolare, nasceva l’Associazione dei Comuni virtuosi. L’idea partiva da un gruppo di amministratori locali – sindaci, assessori, consiglieri – che, ispirati dalle attività della Libera Università di Alcatraz di Jacopo Fo, decisero di fare rete per promuovere politiche pubbliche ispirate ai principi della sostenibilità ambientale, dell’efficienza energetica e della partecipazione attiva dei cittadini.
L’esperienza dei comuni virtuosi, con il suo slogan “Vietato non copiare” è stata anche una di quelle che di più ha ispirato il nostro lavoro con ICC. A vent’anni di distanza, quella rete coinvolge 153 Comuni sparsi per l’Italia, molti dei quali piccoli o piccolissimi, situati nelle aree interne o montane, dove fare politica significa lottare ogni giorno contro lo spopolamento, la riduzione dei servizi, il disinvestimento pubblico. Eppure, come racconta Marco Boschini, co-fondatore e coordinatore dell’Associazione, intervistato da Luca Martinelli per Altreconomia, proprio in questi territori spesso nascono le esperienze più innovative: progetti capaci non solo di migliorare la qualità della vita locale, ma anche di ispirare altri amministratori e cittadini, dimostrando che un altro modo di fare politica è possibile.
Leggetevi l’intervista! La trovate qua sopra, fra le fonti.
Nel luglio 2025 verrà lanciato MicroCarb, il primo satellite europeo dedicato a misurare i flussi di CO₂ nell’atmosfera. Progettato da Francia e Regno Unito, fornirà dati indipendenti per monitorare il rispetto degli impegni climatici internazionali. Obiettivo: capire meglio quanto carbonio viene emesso e assorbito da oceani e foreste. Un passo importante, ma la vera sfida resta trasformare i dati in azione politica.
La Commissione Europea ha lanciato anche – questa volta è un lancio figurato – lo Zero Pollution Dashboard, uno strumento che monitora l’impatto dell’inquinamento su salute, biodiversità e produzione a livello regionale. Fa parte del più ampio Zero Pollution Action Plan, che promuove città più pulite, mobilità sostenibile e soluzioni basate sulla natura. Obiettivo: misurare i progressi, valorizzare le buone pratiche e generare nuove opportunità economiche e turistiche. Le città saranno valutate anche attraverso il Green City Accord.
Infine cinque anni dopo essere stata nominata Capitale Verde Europea, Oslo conferma il suo ruolo di avanguardia climatica urbana. Dal 2009 ha tagliato del 28% le emissioni totali e dell’86% quelle delle attività municipali. Entro il 2030 punta a ridurle del 95%, puntando su foreste, mobilità elettrica, energia e resilienza climatica. Oggi il 90% delle auto nuove è elettrico, il 40% degli spostamenti avviene a piedi e il trasporto pubblico è quasi del tutto a emissioni zero. Oslo investe anche in biodiversità, qualità dell’aria e riuso dei materiali, dimostrando che il cambiamento urbano è possibile.
Segnala una notizia
Segnalaci una notizia interessante per Io non mi rassegno.
Valuteremo il suo inserimento all'interno di un prossimo episodio.











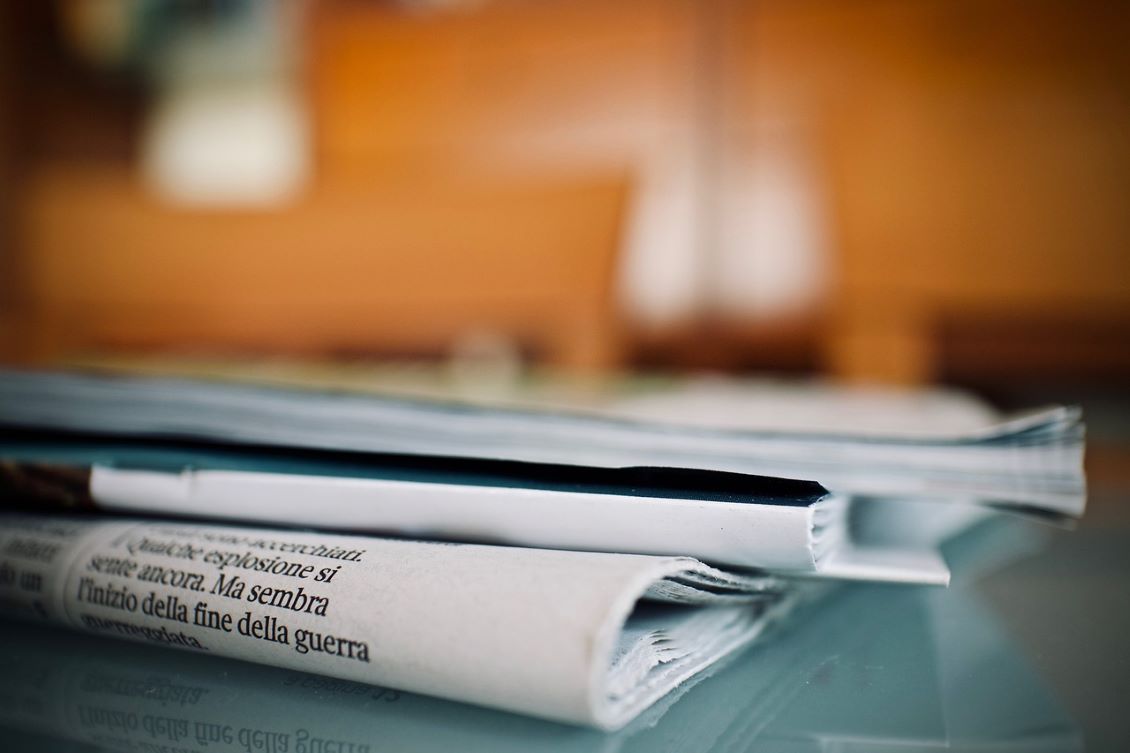

Commenta l'articolo
Per commentare gli articoli registrati a Italia che Cambia oppure accedi
RegistratiSei già registrato?
Accedi