Marine le Pen condannata a 4 anni, non potrà correre per l’Eliseo. Che succede in Francia? – 1/4/2025
Le Pen condannata e fuori dai giochi per il 2027, mentre in Myanmar si teme per Aung San Suu Kyi. Intanto si accende il dibattito sul deep sea mining e cresce il protagonismo politico femminile in Africa.

Questo episodio é disponibile anche su Youtube
Fonti
#Le Pen
il Post – Marine Le Pen è stata dichiarata ineleggibile
Domani – Le Pen condannata per utilizzo fondi Ue: quattro anni di detenzione e cinque di ineleggibilità
#Myanmar
Italia che Cambia – Terremoto in Myanmar: ecco come aiutare
Corriere – Il figlio di Suu Kyi: «Non so più nulla di mia madre. Non fidatevi dei generali, sfrutteranno anche il terremoto»
#Trump
Domani – Trump «molto arrabbiato» con Putin lo minaccia: accordo sull’Ucraina o aumento i dazi
The Guardian – Russia reportedly begins rare earth metals talks with US; Trump ‘very angry’ with Putin – as it happened
#Africa
Il Fatto Quotidiano – Le quattro donne che in Africa stanno al comando e rompono col patriarcato
La notizia ha fatto in poco tempo il giro del mondo e causa un discreto terremoto nella politica francese. Marine Le Pen è stata condannata a 4 anni di reclusione dal Tribunale di Parigi per appropriazione indebita di fondi europei, insieme ad altri 24 membri del suo partito, il Rassemblement National.
L’inchiesta riguarda il periodo tra il 2004 e il 2017, quando Le Pen era europarlamentare. E secondo l’accusa, il RN avrebbe utilizzato alcuni fondi – un bel po’ – destinati agli assistenti parlamentari europei per pagare invece dei collaboratori che in realtà lavoravano per il partito in Francia. Insomma, che non avevano niente a che fare con l’Europa.
L’accusa tira in ballo anche il padre di Marine, Jean-Marie Le Pen, volto storico dell’estrema destra francese morto lo scorso 7 gennaio. Padre e figlia avrebbero orchestrato un sistema per scaricare sui fondi UE i costi dei collaboratori del partito costruendo un sistema di finanziamenti illegali che ha accompagnato l’ascesa del Front National, passato da 3 a 23 eurodeputati in pochi anni.
Questo sistema avrebbe causato un danno di circa 2,9 milioni di euro al Parlamento Europeo.
La sentenza prevede quattro anni di reclusione, di cui due da scontare con braccialetto elettronico, una multa di 100.000 euro e cinque anni di ineleggibilità con effetto immediato, impedendole di candidarsi alle elezioni presidenziali del 2027.
Oltre a Le Pen, altri otto eurodeputati del RN sono stati giudicati colpevoli e dichiarati ineleggibili, fra l’altro con effetto immediato.
Ed è indubbiamente un duro colpo per l’estrema destra francese. Jordan Bardella, presidente del RN, ha definito la sentenza un attacco alla democrazia francese. La condanna ha subito suscitato anche reazioni internazionali: Viktor Orbán ha espresso il suo sostegno scrivendo «Je suis Marine!», mentre il Cremlino ha accusato l’Europa di reprimere le libertà politiche.
Le Pen ha annunciato l’intenzione di presentare ricorso contro la sentenza. Ma l’ineleggibilità immediata complica di molto le sue prospettive politiche future perché finché non vincerà un eventuale appello non potrà comunque candidarsi alle elezioni locali o nazionali per cinque anni, incluse le elezioni presidenziali del 2027. E non è per niente scontato che la sentenza in appello arrivi in tempi utili per candidarsi alle presidenziali del 2027.
Come commenta il Post, “La condanna all’ineleggibilità è una notizia grossa, anche perché Le Pen sembrava la grande favorita a vincere le prossime presidenziali. Mancano due anni ed è presto per prendere troppo sul serio i sondaggi, ma vanno tenute a mente due cose: il Rassemblement National non è mai stato così popolare, ed è stato il singolo partito più votato alle elezioni legislative dell’anno scorso”. Un sondaggio recente la dava in testa con oltre il 34% dei consensi al primo turno per la corsa alle presidenziali del 2027.
Adesso tutto cambia.
Spesso denunciamo come i giornali e i tg riportino solo cattive notizie. E gli effetti che queste hanno sulla mente di chi le ascolta. Se vogliamo dirla tutta però, non si tratta nemmeno e solo di questo. Perché anche nelle cattive notizie, ci sono notizie e paesi di serie A e di serie B.
Non so se ci avete fatto caso ma ad esempio la tragedia del terremoto in Myanmar, che ha causato una devastazione e una quantità di morti, feriti e distruzione gigantesca – parlaimo di oltre 2mila morti accertati – è scomparsa quasi immediatamente dalle prime pagine dei giornali.
Provo un senso di profonda ingiustizia quando succede questo. Non è solo colpa dei media, intendiamoci: un po’ dipende anche da quanto i paesi in cui questi disastri avvengono forniscono e raccontano storie e informazioni, un po’ dipende da un senso di vicinanza o distanza culturale, che non c’entra con quella geografica, che noi tutti avvertiamo rispetto a certi luoghi. Ma i media giocano comunque un ruolo cruciale, e fatto sta che i posti più poveri e meno fortunati, sono anche quelli di cui tendiamo a preoccuparci di meno.
Comunque tutto questo per dire che invece è importante continuare a raccontare quello che accade in Myanmar anche perché è un modo per ricordarci che possiamo aiutare.
Su questo tema ho trovato interessante un’intervista del Corriere a Kim Aris, figlio secondogenito di Aung San Suu Kyi, leader storica del paese e premio Nobel per la Pace, messa in carcere dalla giunta militare che ha fatto il colpo di stato 4 anni fa.
In questa intervista Kim Aris, che si trova negli Stati Uniti dove sta raccogliendo fondi per la causa birmana, racconta di non avere notizie dirette della madre e che teme che la giunta militare possa approfittare del terremoto per farla sparire definitivamente. «Mi dicono che sia agli arresti domiciliari, ma è una bugia: è ancora in prigione. In quattro anni ho ricevuto solo una sua lettera».
Fra l’altro Aris solleva anche un altro problema, ovvero la gestione degli aiuti da parte della giunta: in pratica spesso gli aiuti internazionali finiscono nelle mani dei militari, che li usano per rafforzare il controllo o punire chi considerano nemici. Quindi è importante, se vogliamo donare, farlo a delle organizzazioni di cui siamo sicuri.
Io vi rimetto sotto Fonti la news in cui indichiamo alcune organizzazioni sicure a cui fare una donazione. L’intervista ad Aris si conclude con una nota di speranza. Prima o poi – dice – il popolo si libererà dei generali. E solo allora mia madre tornerà libera. Il suo destino è legato a quello della Birmania.
C’è un nuovo fronte caldo nel già acceso dibattito sull’estrazione mineraria nei fondali oceanici, una pratica nota come deep sea mining. Al centro della discussione ci sono i lavori in corso in questi giorni a Kingston, in Giamaica, dove si sta tenendo la trentesima sessione del Consiglio dell’Autorità internazionale per i fondali marini (ISA), l’organismo delle Nazioni Unite incaricato di regolare lo sfruttamento delle risorse nei fondali marini internazionali.
Proprio durante questi incontri, la compagnia mineraria The Metals Company ha annunciato che presenterà una richiesta di autorizzazione all’estrazione in acque profonde non attraverso le regole dell’ISA, ma basandosi su una vecchia normativa statunitense degli anni ’80.
Ma che cos’è esattamente il deep sea mining? Si tratta dell’attività estrattiva condotta nelle profondità oceaniche, in genere a migliaia di metri sotto la superficie del mare, per recuperare metalli e minerali preziosi come nichel, cobalto, rame e terre rare. Questi materiali sono considerati strategici per la transizione energetica, in quanto componenti fondamentali per batterie, pannelli solari, turbine eoliche e dispositivi elettronici.
Le aziende minerarie, come la canadese The Metals Company, sono particolarmente interessate ai noduli polimetallici presenti sul fondo oceanico, specialmente in aree come la Zona di Frattura di Clarion-Clipperton, nel Pacifico. Si tratta di concrezioni di minerali formatesi in milioni di anni, depositate su vaste distese abissali. La prospettiva di poter accedere a queste risorse senza dover dipendere da filiere terrestri spesso instabili o geopoliticamente sensibili ha spinto diverse compagnie a premere per l’avvio delle attività estrattive.
È in questo contesto che si inserisce la mossa di The Metals Company, che durante i lavori dell’ISA ha annunciato l’intenzione di presentare una richiesta di autorizzazione all’estrazione non seguendo le regole multilaterali dell’ISA, ancora in via di definizione, ma appellandosi a una vecchia normativa statunitense degli anni ’80. Una mossa che suona come un tentativo di forzare la mano alla comunità internazionale, accelerando i tempi e bypassando il negoziato in corso.
Se approvata, questa scelta rischierebbe di aprire una pericolosa breccia nel già fragile quadro regolatorio internazionale, creando un precedente che potrebbe incentivare altre aziende a fare lo stesso. L’ISA, infatti, non ha ancora adottato un vero e proprio codice minerario, ma diverse delegazioni e organizzazioni chiedono che si proceda con cautela, considerando i potenziali impatti ambientali e sociali dello sfruttamento degli abissi marini.
In questo scenario, le critiche da parte di Greenpeace e di altri attori della società civile sono dure. L’organizzazione ambientalista denuncia quello che definisce un tentativo di sabotaggio del multilateralismo, e rinnova l’appello per una moratoria globale sul deep sea mining, per proteggere un ecosistema ancora in gran parte sconosciuto, ma fondamentale per la salute dell’oceano e del pianeta.
Nel frattempo, il 28 marzo, si sono chiusi i lavori della trentesima sessione dell’ISA, che avrebbe dovuto portare avanti proprio la definizione del quadro normativo internazionale per l’estrazione mineraria in acque profonde. E che ancora langue. Il rischio però è che alla lentezza dei processi multilaterali internazionali si contrapponga la sfrontatezza predatoria di alcune aziende. Urge, come chiede Greenpeace, una moratoria internaizonale per bloccare ogni estrazione in attesa di un accordo.
I giornali continuano a parlare molto di Trump, dei dazi, dei colloqui per l’Ucraina. Ovviamente a stare dietro a quello che dice Trump c’è sempre qualcosa da dire, ma poi contano i fatti e di fatti per adesso non c’è stato granché.
Forse il fatto più eclatante della settimana su quel fronte è stato che Mike Waltz, consigliere per la sicurezza di Trump – per la sicurezza – ha inserito per errore l direttore dell’Atlantic, un importante magazine statunitense, in una chat super riservata su Signal in cui si decideva la strategia su come attaccare e bombardare gli Houthi in Yemen.
La notizia ha ovviamente fatto il giro del mondo per la sua paradossalità. Però insomma, ha qualcosa da dirci. E non solo che forse il consigliere alla sicurezza dovrebbe stare un po’ più attento, ma anche che l’amministrazione Usa comunica e prende decisioni di importanza molto alta, e che coinvolgono dati sensibili di diverse persone, su una chat di un programma di messaggistica. Che è sì sicuro, crittato e quello che volete, insomma non sarà Whatsapp, però ecco, non stiamo parlando del gruppo di calcetto del giovedì sera, stiamo parlando di un attacco militare.
L’altra notizia rilevante è la dichiarazione di Trump che ha detto di essere molto arrabbiato con Putin. Che in sé non è che sia una roba così interessante, ma mi ha colpito leggere le dichiarazioni, le parole usate dal Presidente perché ci dicono molto sulla sua concezione di politica estera.
In un’intervista a NBC, Trump ha detto, «Se io e la Russia (sottolineo IO) non dovessimo riuscire a raggiungere un accordo per fermare lo spargimento di sangue in Ucraina e se dovessi pensare che è colpa della Russia allora applicherò tariffe secondarie sul loro petrolio». Trump ha detto che Putin sa della sua arrabbiatura, che ci parlerà in settimana, ma ha aggiunto che la rabbia può «dissiparsi rapidamente» se Putin «fa la cosa giusta».
“Io e la Russia”, “se dovessi pensare”, “arrabbiatura”. Sono tutti termini che mostrano una politica estera fatta di questioni personali e sull’onda del momento. Il problema con Trump è che nessuno sembra aver capito – probabilmente nemmeno lui – quanto usi questo lessico molto personale per poi far passare questioni più generali oppure quanto riduca davvero le relazioni diplomatiche a come si sveglia la mattina.
Sul fronte iraniano, il linguaggio è ancora più bellicoso: se non verrà trovato un accordo sul nucleare, ha dichiarato, “ci saranno bombardamenti come non se ne sono mai visti”. Parole che arrivano mentre sono in corso colloqui tra Stati Uniti e Iran, e che contrastano con il fatto che fu lo stesso Trump, nel suo primo mandato, a far saltare l’accordo sul nucleare firmato da Obama.
Nel frattempo, Trump conferma l’intenzione di far partire dal 2 aprile una nuova ondata di dazi contro le auto straniere, incurante dei rincari che potrebbero colpire le fasce più povere della popolazione. Anzi, ha detto di sperare che i prezzi salgano, così “la gente comprerà auto americane”.
Chiudiamo con un articolo che voglio leggervi quasi per intero, perché è breve, conciso, ma traccia un quadro interessante dei cambiamenti in corso nel continente africano. Lo scrive Stefano Pancera sul Fatto Quotidiano:
“Quattro donne africane sono oggi le moschettiere del continente. Prima fra tutte la neo presidente della Namibia, Netumbo Nandi-Ndaitwah, eletta al primo turno con il 57,31% dei voti. Quinta presidente della Namibia dal 1990 e prima donna a ricoprire la carica, ha dato vita a un governo con una significativa presenza femminile. “Come leader eletti, abbiamo la responsabilità di consolidare la democrazia. L’uguaglianza di genere non è un tema simbolico, è una leva per lo sviluppo e la stabilità”, ha dichiarato, tracciando una visione in cui il protagonismo femminile è strategia nazionale. Non a caso, il Parlamento namibiano è tra i più equilibrati al mondo: oltre il 44% dei seggi è occupato da donne.
Dopo la sua elezione, Netumbo Nandi-Ndaitwah. ha subito nominato diverse donne ai vertici del Paese: Lucia Witbooi come vicepresidente, e altre donne a capo di ministeri chiave, tra cui quello delle Finanze, del Commercio, delle Comunicazioni e, dulcis in fundo, il Ministero dell’Uguaglianza di Genere — sì, in Namibia esiste un Ministero dedicato proprio all’Uguaglianza di Genere. Con questo governo, la Namibia si colloca tra i Paesi africani che più stanno investendo nel protagonismo femminile nelle istituzioni.
Più a nord, Samia Suluhu Hassan guida la Tanzania dal 2021 con un pragmatismo che ha zittito gli scettici: una delle poche leader africane con pieni poteri esecutivi, governa senza rinnegare il velo islamico né il ruolo di “madre della nazione”. In Tunisia, Sarra Zaafrani Zenzri sfida gli equilibri del Maghreb da prima ministra, mentre nella tormentata Repubblica Democratica del Congo Judith Suminwa Tuluka, prima premier donna della storia, ha scelto come motto “dar voce a chi non ha mai avuto diritto alla parola”.
Sono scelte che tracciano una mappa nuova: non semplici nomine, ma atti di rottura con secoli di patriarcato radicato tanto nella cultura tradizionale quanto nel retaggio coloniale. Casi fortuiti o un segno dei tempi? A mio avviso un segnale importante che segna la rottura di vecchi stereotipi (sia culturali che religiosi) per cui la donna in Africa non conta.
Segnala una notizia
Segnalaci una notizia interessante per Io non mi rassegno.
Valuteremo il suo inserimento all'interno di un prossimo episodio.






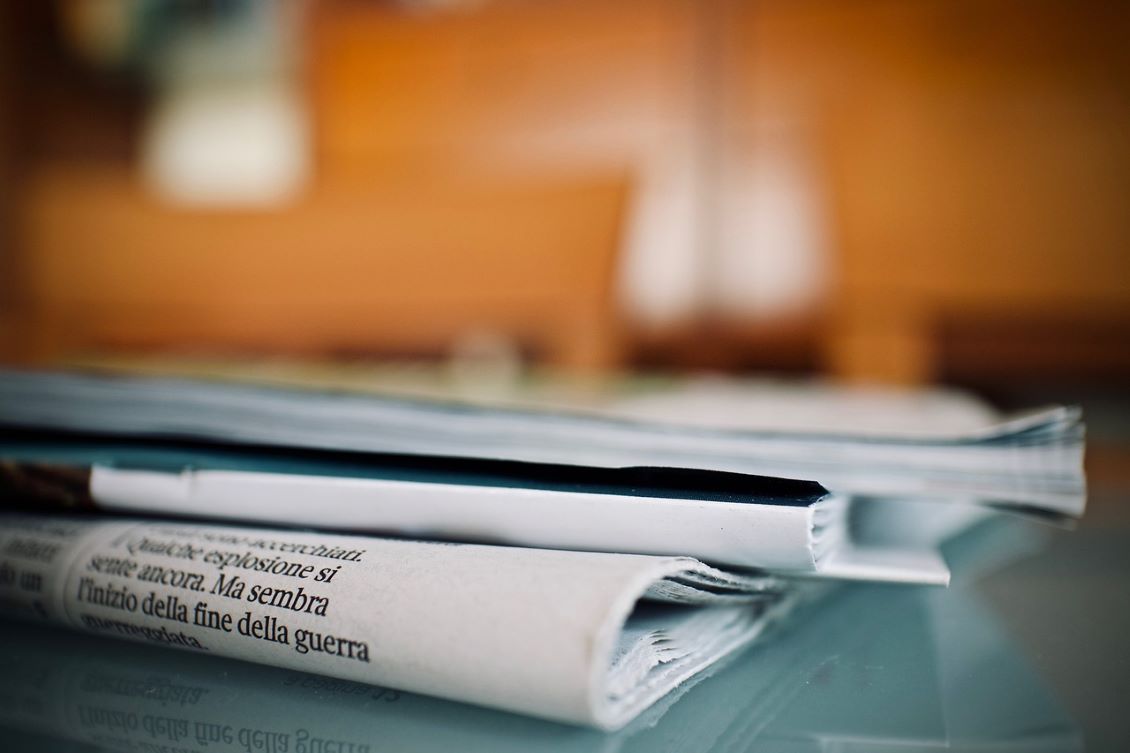







Commenta l'articolo
Per commentare gli articoli registrati a Italia che Cambia oppure accedi
RegistratiSei già registrato?
Accedi