Femminicidi e media, fra silenzi e allarmismi. Cosa dicono i numeri? – 4/4/2025
Femminicidi, sinodo e transizione verde: tre storie che mostrano come patriarcato, potere e industria convivano sotto narrazioni contraddittorie.

Questo episodio é disponibile anche su Youtube
Fonti
#femminicidi
il Post – In Italia abbiamo un problema con i dati sui femminicidi
il Post – Cos’è un “femminicidio”
Pagella Politica – È vero: il numero dei femminicidi è stabile
Italia che Cambia – Femminicidi, misoginia e inadeguatezza delle Istituzioni
Il Sole 24 Ore – In Italia cala il numero di omicidi, ma non quello dei femminicidi
#Chiesa
la Repubblica – Rivolta al sinodo italiano: salta il testo finale su donne, gay e trasparenza. Assemblea riconvocata
#carbone verde
il Post – Com’è cambiata una comunità brasiliana per colpa del carbone vegetale
#Sardegna
Italia che Cambia – 6mila militari da 8 Paesi Nato e oltre 120 mezzi: inizia la Mare Aperto 2025 – INMR Sardegna #72
Allora, dobbiamo parlare di femminicidi. Perché è un tema molto caldo che devo dire la stampa tratta abitualmente abbastanza male, oscillando fra due tendenze apparentemente opposte, ma entrambe molto emotive e in modo diverso – credo – dannose e disfunzionali.
Le due maniere – che a volte persino coesistono – sono a) minimizzare / colpevolizzare la vittima e b) fare allarmismo e gridare alla strage.
Comunque, partiamo come sempre dal punto 0. Si sta parlando molto di femminicidi negli ultimi giorni per due tragici fatti di cronaca: l’uccisione di due giovani donne, Sara Campanella e Ilaria Sula, uccise a poco più di 24 ore di distanza e con molte analogie.
Sara Campanella era una studentessa di infermieristica di 22 anni, uccisa il 31 marzo a Messina da Stefano Argentino, 27 anni, ex collega universitario,che l’ha accoltellata in pieno giorno mentre lei tornava dal tirocinio ospedaliero. Argentino aveva perseguitato Sara per circa due anni con attenzioni indesiderate e messaggi ossessivi.
Ilaria Sula, anche lei 22enne e studentessa universitaria, era scomparsa invece il 25 marzo a Roma. Il suo corpo è stato ritrovato giorni dopo, chiuso in una valigia e abbandonato in un dirupo a circa 40 km dalla capitale. In questo caso è l’ex fidanzato, Mark Antony Samson, 23 anni, che ha confessato l’omicidio.
Questi due casi, con le loro analogie, le vittime entrambe giovanissime, con la stessa identica età, hanno sconvolto l’opinione pubblica e riacceso il dibattito sul femminicidio. Fra l’altro è un dibattito anche politico, perché il 7 marzo scorso il Consiglio dei ministri ha approvato un disegno di legge per introdurre nel codice penale italiano il reato di femminicidio punito con l’ergastolo, cioè con il carcere a vita.
Come vi dicevo però il dibattito è molto emotivo. Che da un lato è inevitabile, su un tema così tremendo e delicato. Ma proprio per questo la stampa dovrebbe sforzarsi di essere molto razionale, non alimentare ma in qualche modo controbilanciare questa tendenza con dati e analisi oggettive.
E invece mi sembra che spesso faccia l’opposto (con eccezioni, ovviamente eh). Sul minimizzare, abbiamo un sacco di esempi:
Su alcune testate si legge ad esempio che l’omicidio di Sara sarebbe collegato a un post che la vittima stessa aveva scritto, riconducibile a un forte desiderio di indipendenza. Ovvero: “Mi amo troppo per stare con chiunque”.
E ancora, leggo, “Sara non aveva denunciato”, “Non si era accorta del pericolo”. Come sottolinea l’associazione D.i.Re Donne in Rete contro la violenza in uno dei post pubblicati su facebook, si tratta di «dichiarazioni che tendono a colpevolizzare la donna evitando di centrare l’attenzione sul sistema preventivo inadeguato>>.
Dall’altro lato però come vi dicevo, noto anche la tendenza opposta, quella dell’allarmismo, che porta ad esempio tanti giornali a gridare alla strage. Una dinamica che probabilmente in parte è dettata anche dalla volontà di accendere i riflettori su questo fenomeno, ma che induce le persone a pensare che quello dei femminicidi sia un fenomeno in costante crescita e del tutto fuori controllo.
Poi, in modo trasversale a queste due tendenze, e che le accompagna entrambe, c’è una roba un po’ morbosa, ovvero la sovraesposizione di fotografie delle vittime, una tendenza accentuata soprattutto quando le vittime in questione sono giovani e di bell’aspetto.
Il che mi spinge anche un po’ a pensare che in fin dei conti, sia che si minimizzi e si colpevolizzi la vittima, sia che si gridi alla strage, il fine ultimo sia quello di acchiappare più click possibili parlando alla pancia delle persone.
Comunque, visto che a criticare son buoni tutti, cerchiamo di rimettere le cose in fila e fare dei ragionamenti basati sui dati. Per capire se effettivamente c’è una emergenza legata ai femminicidi e quanto è grande.
La prima cosa con cui ci si scontra quando si cerca di capire questa cosa è la difficoltà nel reperire i dati. In Italia infatti non esiste una banca dati istituzionale, pubblica e completa sui femminicidi. Come spiega un articolo del Post, le due fonti ufficiali – Istat e Ministero dell’Interno – sono disomogenee, poco aggiornate e seguono criteri diversi. L’Istat pubblica un report annuale ogni 25 novembre, mentre il Ministero aggiorna i dati sugli omicidi volontari (classificati per sesso e relazione con il colpevole) che, fino a dicembre 2024, erano settimanali, poi mensili, e ora diventeranno trimestrali, senza spiegazioni pubbliche a questo cambiamento.
In questo vuoto istituzionale si inserisce l’Osservatorio di Non Una di Meno, che raccoglie dati “dal basso” aggiornandoli ogni mese con metodi autonomi e approfonditi, scavando nelle cronache locali e filtrando le notizie mistificate. L’Osservatorio monitora anche lesbicidi, transcidi, suicidi indotti, tentati femminicidi, orfani, storie marginalizzate (come le sex worker), e analizza le dinamiche alla base di quella che definisce violenza patriarcale.
Il problema però non è solo che mancano i dati per superficialità o mancata volontà politica. Il problema è che la parola “femminicidio” non ha una valenza giuridica specifica e non è nemmeno facile dargliela. Femminicidio è, per come viene comunemente inteso, è l’omicidio di una donna alla cui origine ci sia una dinamica di sopraffazione, controllo o possesso derivata dal ruolo di subordinazione rispetto agli uomini. Non è quindi un generico omicidio di una donna. Ma un delitto figlio di una certa cultura, una certa idea di relazione malata fra uomo e donna.
Quindi si capisce che non è facile determinare cosa è femminicidio e cosa non lo è in maniera certa. Non è semplice capire qual è il movente principale di un omicidio, perché siamo esseri complessi, pieni di pulsioni, e non è facile tracciare una linea fra un delitto che è in qualche misura figlio della cultura patriarcale e un altro che invece è dettato da una mente malata sulla quale però non influisce quel tipo di cultura del possesso.
L’unico dato certo da cui possiamo partire è quello degli omicidi e degli omicidi di donne. I dati generali degli omicidi in Italia sono calati molto in Italia. Si è passati da 711 omicidi nel 2004 a 334 nel 2023. Anche gli omicidi con vittime femminili sono diminuiti, anche se un po’ meno, in percentuale. Erano 186 nel 2004, quindi circa il 26% del totale. Sono state 117 nel 2023, quindi il 35%.
Comunque, tutti gli omicidi sono in calo. Ora quali di questi però posso essere considerati femminicidi? Eh, qui le stime divergono. E soprattutto questa specifica tipologia di omicidio viene conatta statisticamente solo dal 2019. Dal 2019 ad oggi i dati sono rimasti abbastanza stabili, ma variano di molto a seconda delle stime.
Istat dice che nel 2019 sono stati 101, nel 2020 106, nel 2021 104, nel 2022 105 e nel 2023 96. L’osservatorio Non Una di Meno fornisce dei dati leggermente differenti, ad esempio ne conta 113 nel 2021, 105 nel 2022, 104 nel 2023 e 97 nel 2024. Mentre il sito La Fionda, che utilizza criteri molto più stringenti, e forse fa un’operazione anche un po’ strumentale, però ne conta 39 nel 2019 e ad esempio 26 nel 2024.
Questo per dire che qualsiasi criterio usiamo i dati sono tendenzialmente stabili, forse anche in leggero calo.
Questo vuol dire che non esiste nessun problema di violenza di genere o che il patriarcato è solo un’invenzione delle femministe? Assolutamente no, ed è sacrosanto lottare perché questi cento casi all’anno diventino zero. E non è solo una questione di omicidi, ovviamente, il maschilismo si vede ancora in tanti aspetti della nostra società.
Al tempo stesso, da giornaliste e giornalisti abbiamo credo il dovere di non farci prendere da allarmismi, non parlare alla pancia e cercare di riportare le questioni a dati, analisi oggettive, osservazioni. Fatemi sapere cosa ne pensate.
Restiamo in tema di questioni di genere, ma cambiamo contesto. Parliamo della chiesa. In questi giorni, a San Pietro, si è consumato un evento inedito nella storia recente della Chiesa italiana: una vera e propria rivolta sinodale.
Ora, non immaginatevi una scazzottata alla Bud Spencer, o una rivoluzione zapatista, ma comunque è stata una roba grossa.
Comuqnue, partiamo dal principio. Nel 2021, Papa Francesco ha lanciato il Sinodo mondiale sulla sinodalità. What? Sì, sembra un po’ uno scioglilingua ma in pratica è un processo che coinvolge tutte le Chiese locali nel mondo e che doveva durare fino al 2024 (ma forse oltre, già si diceva), per rinnovare la Chiesa.
In pratica era un percorso di ascolto delle comunità cattoliche sparse per il mondo per ascoltare e poi recepire i cambiamenti della fede, a partire dal basso, dalle parrocchie.
In Italia, su impulso del Papa, la CEI (Conferenza Episcopale Italiana) ha avviato il suo cammino sinodale nazionale. E nei giorni scorsi è stata convocata in Vaticano la seconda assemblea del cammino sinodale della Chiesa italiana.
Durante questa assemblea gli uffici della CEI avevano preparato un documento finale che avrebbe dovuto raccogliere e sintetizzare quattro anni di ascolto, confronti e consultazioni capillari nelle diocesi di tutto il Paese.
Solo che i più di mille delegati, oltre la metà dei quali laici, hanno detto votato un sonoro NO, bocciando il documento. Ed è una cosa abbastanza inedita! E non si tratta di un capriccio o di un problema di forma. Il testo è stato giudicato generico, evasivo, eccessivamente prudente, incapace di restituire il senso profondo del cammino fatto finora. «Sembrava scritto 40 anni fa», ha detto a Repubblica uno dei partecipanti.
Ma quali i nodi – o i sinodi – del contendere? I temi cruciali che erano emersi con forza nelle consultazioni di base erano il ruolo delle donne, il riconoscimento delle persone LGBTQ+, la trasparenza economica, gli abusi, i temi sociali come lavoro, ambiente e migrazioni. Solo che nel documento finale, denunciano i partecipanti, sono stati affrontati in modo vago o elusivo.
Si parlava sì del valore delle donne, ma senza nessun accenno al diaconato o a nuovi ministeri femminili. C’era un cenno all’“accompagnamento” delle persone omosessuali, ma nessuna menzione esplicita delle sigle LGBTQ+, né un’apertura chiara su inclusione e riconoscimento. E sugli abusi sessuali nella Chiesa, ancora meno: si delegava tutto alle singole diocesi.
Insomma, il documento appariva troppo cauto, troppo “curiale”, per usare un termine ecclesiastico. Un testo che, anziché valorizzare il pluralismo emerso, sembrava appiattirsi sul minimo comune denominatore. E questo ha fatto esplodere il dissenso.
Il momento clou è arrivato martedì: si erano iscritti a parlare 150 delegati, ne hanno parlato solo 50, ma tanto è bastato per far crollare il castello. Monsignor Erio Castellucci, presidente del comitato del sinodo, a quel punto ha aperto alla possibilità di presentare tutti gli emendamenti. Risultato: una valanga di modifiche, che ha messo in evidenza l’insostenibilità del testo. A quel punto, si è deciso: si riscrive tutto da capo. La CEI ha sconvocato l’assemblea di maggio e rimandato tutto a ottobre.
Il nuovo appuntamento è fissato per il 25 ottobre, e in quell’occasione si voterà un nuovo documento, riscritto radicalmente. L’assemblea ha approvato questa decisione con 835 voti favorevoli, solo 12 contrari.
Dietro a questa scossa, commenta l’articolo di Repubblica, c’è anche la spinta data da Papa Francesco, che da anni insiste sulla sinodalità, cioè su una Chiesa meno verticistica, più partecipata, più capace di ascoltare. Ed è una cosa interessante.
Il cammino sinodale italiano è partito a fatica, nel 2021, su stimolo del Papa. Ma per lungo tempo è sembrato un esercizio formale, poco incisivo. Adesso, però, qualcosa si muove davvero nella chiesa. E lo dimostra questa sorta di ribellione, che ci racconta quanto stia cambiando la dinamica ecclesiale: non più solo attesa passiva di decisioni dall’alto, ma partecipazione critica, che chiede riforme vere.
Che appunto è interessante, soprattutto in un momento storico in cui la partecipazione democratica è piuttosto bassa, mostra una vitalità quasi inaspettata.
Il Post pubblica un reportage molto interessante scritto da 3 giornalisti Simone Fant, Emmanuelle Picaud e Daniel Camargos e finanziato grazie ai fondi europei per il giornalismo Journalismfund Europe, su come una comunità brasiliana è cambiata per colpa del carbone vegetale.
Provo a riassumervi la storia, ma vi consiglio di andarvi a leggere tutto il reportage, se avete tempo. È un po’ lungo ma davvero interessante.
In pratica nel cuore del Minas Gerais, in Brasile, un villaggio un tempo ricco di acqua e biodiversità – Poço de Água – oggi soffre la sete. La storia prende il via da una vicenda personale, quella di João Gomes de Azevedo e della sua famiglia, che negli anni ’70 videro arrivare le piantagioni di eucalipto promosse dalla dittatura militare brasiliana per alimentare l’industria dell’acciaio.
E così prima Acesita, oggi Aperam – controllata da ArcelorMittal – ha trasformato questo angolo di selva del Cerrado, un bioma ricco di vita e sorgenti d’acqua, in una distesa di eucalipti alti venti metri.
Che c’entra l’eucalipto con l’acciaio, direte voi? C’entra. perché le acciaierie vanno alimentate con combustibili molto potenti, per raggiungere le temperature necessarie. E l’eucalipto è una sorta di alternativa “green” si fa per dire, al carbone. Perché dall’eucalipto (anche da altri legnami ma l’eucalipto per alcune sue caratteristiche è particolarmente adatto) si ricava il cosiddetto carbone vegetale. Che è un tipo di carbone che si ottiene carbonizzando il legno – cioè bruciandolo in assenza di ossigeno – ed è utilizzato in vari settori, ma in Brasile ha un ruolo chiave nella produzione dell’acciaio.
Solo che queste monocolture di eucalipto prosciugano le falde, inquinano i corsi d’acqua e riducono drasticamente la biodiversità. Secondo uno studio, l’invasione dell’eucalipto ha causato un calo della falda di 4,5 metri in 45 anni e ridotto l’acqua sotterranea di 31 miliardi di litri l’anno.
La cosa peggiore è che il tutto avviene sotto il cappello della sostenibilità: le piantagioni sono certificate FSC, (Forest Stewardship Council) che è un marchio internazionale che garantisce che i prodotti in questione provengano da una gestione forestale responsabile, sia dal punto di vista ambientale che sociale ed economico. Ma secondo le comunità locali e diverse ONG, è puro greenwashing.
Aperam dal canto suo non riconosce i danni, e continua a produrre acciaio con carbone vegetale, vende crediti di carbonio, e si propone come leader della transizione verde perché dice di usare un biocarburante. Ma chi vive a Poço de Água e dintorni è sempre più spesso costretto a comprare taniche d’acqua e racconta un’altra verità: l’acciaio che vuole salvare il clima sta distruggendo la loro terra e la loro acqua.
Insomma, una storia emblematica di come dietro alle soluzioni “verdi” dell’industria si nascondano spesso interessi economici e impatti sociali e ambientali pesantissimi. E di come la transizione ecologica non sia esente da contraddizioni.
Che da una parte è un bene: il fatto che ci siano contraddizioni significa che in qualche forma sta avvenendo. Ed è importante non confondere la fondamentale denuncia delle contraddizioni, delle ingiustizie, delle assurdità, con la negazione che la transizione ecologica sia una roba necessaria.
Segnala una notizia
Segnalaci una notizia interessante per Io non mi rassegno.
Valuteremo il suo inserimento all'interno di un prossimo episodio.










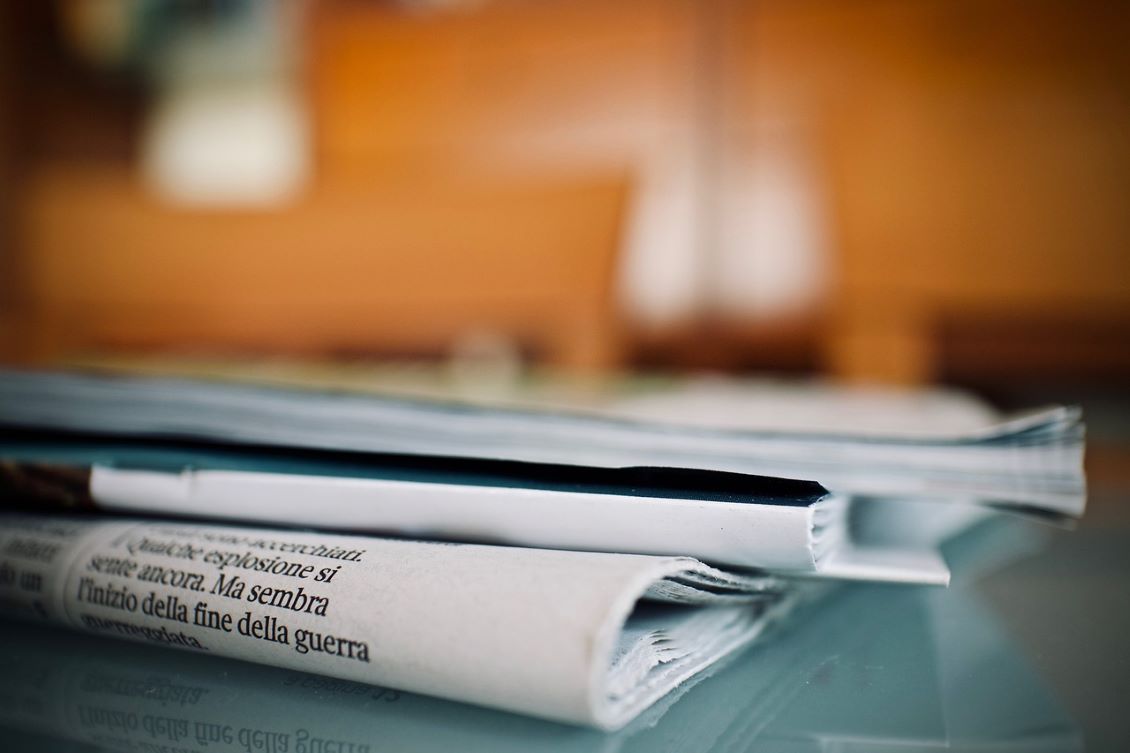



Commenta l'articolo
Per commentare gli articoli registrati a Italia che Cambia oppure accedi
RegistratiSei già registrato?
Accedi