L’importanza dei fondi di coesione e il piano di riarmo in uno scenario europeo in cambiamento
La proposta della Commissione europea di reindirizzare parte dei fondi di coesione verso il rafforzamento della difesa comune, mette in discussione le priorità dell’UE e rischia di compromettere il sostegno a territori come la Sardegna.

Nelle ultime settimane è tornata all’attenzione mediatica la politica di coesione promossa dall’Unione Europea, al centro di un dibattito pubblico per l’intenzione dell’attuale Commissione di includere le sue risorse tra quelle previste per il piano di riarmo europeo. Definita con una riforma del 1988, la suddetta politica ha in origine il fine di creare dei Programmi Operativi con obiettivi prioritari e geografici.
I fondi di coesione nascono dunque allo scopo di rafforzare la coesione economica, sociale e territoriale dell’Unione per promuovere lo sviluppo dei paesi membri e ridurre il divario tra i diversi territori europei. Ma senso e obiettivi di questa politica, appaiono ad oggi in evidente contrasto con le recenti intenzioni della Commissione. Andiamo per gradi.
Finanziamenti alla difesa, la nota stonata
A inizio marzo la Presidente Von der Leyen ha inviato agli Stati membri la proposta del nuovo Piano Rearm Europe, finalizzato al rafforzamento della difesa dei singoli Stati. Alla proposta è seguita la pubblicazione di un Libro Bianco sulla difesa e prontezza europea 2030 che prevede, tra le modalità di finanziamento del Piano, la possibilità di riallocare fondi e risorse disponibili nel bilancio pluriennale 2021-2027 attualmente destinati ad altri scopi. Tra questi anche i Fondi di Coesione.

L’indirizzo espresso da Von der Leyen inizia a prendere forma, in particolare nella proposta di riforma illustrata il Primo aprile dal commissario alla politica regionale e di coesione Raffaele Fitto, che ha presentato al Parlamento europeo lo scenario che permetterebbe di dirottare circa 400 miliardi di euro del periodo 2021-27 per finanziare difesa, competitività, politiche abitative, resilienza dell’acqua e transizione energetica.
Se sulle politiche abitative e quelle legate alla transizione può esserci un legame di senso con i fondi di coesione, ciò che spicca è il finanziamento alla difesa, che appare la vera nota stonata della proposta. La scelta della Commissione è stata criticata da più parti e osteggiata non solo da alcuni governi nazionali, ma anche da importanti organismi come il Comitato delle Regioni e l’assemblea dei rappresentanti locali e regionali dell’Unione Europea, che consente agli enti substatali di far sentire la propria voce in maniera diretta all’interno del quadro istituzionale europeo.
Un evidente snaturamento del senso dei fondi di coesione
Il piano è su base volontaria e spetterà agli Stati decidere se cogliere queste proposte che – immagino – saranno caldeggiate e facilitate da incentivi finanziari vantaggiosi o dall’aumento della percentuale degli anticipi alla quota del cofinanziamento. La proposta della Commissione per diventare operativa dovrà però prima essere accettata dal Consiglio Europeo e dal Parlamento; solo allora gli Stati potranno presentare i loro programmi. I tempi previsti sono piuttosto lunghi: l’obiettivo è far partire i nuovi progetti dal 2026.
La scelta della Commissione appare quindi un evidente snaturamento del senso dei fondi di coesione, nati allo scopo di ridurre divari e disparità tra territori e regioni europee – in particolare nelle aree meno sviluppate – per aumentare le opportunità di sviluppo economico e sociale per le comunità più fragili. Non dovrebbero essere visti come una facile fonte da utilizzare per riallocare risorse, questa volta per finanziare le ambizioni di difesa, ma come uno strumento concreto e strategico per costruire un contesto di stabilità e di pace.
Fondi e Stati membri
Per raggiungere gli obiettivi della coesione, l’UE stipula accordi di partenariato con i singoli Stati membri e, secondo regole condivise, assegna in un arco temporale di sette anni – il cosiddetto Ciclo di programmazione – specifiche risorse finanziarie a cui si aggiungono quelle nazionali messe a disposizione dagli Stati.

In Italia il cofinanziamento nazionale è assicurato per la maggior parte dal Fondo nazionale di rotazione per l’attuazione delle politiche comunitarie, a cui si somma il Fondo Sviluppo e Coesione, che stanzia risorse addizionali per sostenere e sviluppare le politiche di coesione e territoriali. I principali fondi strutturali che sostengono la politica di coesione sono: il Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale (FESR), il Fondo per una transizione giusta (Just Transition Fund – JTF), il Fondo Sociale Europeo Plus (FSE+), il Fondo Europeo per gli Affari Marittimi, la Pesca e l’Acquacoltura (FEAMPA). I primi due saranno i fondi ai quali attingere per la difesa, nelle intenzioni della Commissione.
All’Italia in questo ciclo di programmazione sono assegnati nel complesso 43,6 miliardi di euro: circa 42,7 sono destinati a promuovere la coesione economica, sociale e territoriale, con una assegnazione particolarmente rilevante per le regioni meridionali, cui sono dedicati più di 30 miliardi di euro del FESR e del FSE+, dei complessivi 41,1 miliardi dei due Fondi.
Le risorse vengono assegnate alle singole regioni sulla base dell’appartenenza a tre categorie: regioni meno sviluppate, in transizione e più sviluppate. Nell’attuale programmazione, tra le meno sviluppate – il cui PIL pro capite è inferiore al 75 % della media UE di tutti i 27 Stati membri – vengono ricomprese oltre Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia, anche Sardegna e Molise, precedentemente tra le regioni in transizione.

Fondi di coesione, centrali per l’Isola
Nel ciclo 2021-2027 la Sardegna è tornata quindi fra le regioni “meno sviluppate” e questo ha significato un aumento delle risorse a disposizione. La Regione ha definito le proprie strategie programmatiche attraverso la redazione dei Programmi Regionali FESR e FSE+ 2021-2027, che seguono la direzione tracciata dal Programma Regionale di Sviluppo (PRS 2020-2024), il quale è a sua volta stato redatto tenendo conto degli obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite e della Smart Specialisation Strategy (S3), come quadro strategico per le politiche di ricerca, sviluppo tecnologico e innovazione. Ma di quante risorse parliamo?
La dotazione complessiva del FESR è quasi raddoppiata rispetto al precedente ciclo di programmazione: da 930,9 milioni nel 2014-2020 è passata a 1.581 milioni nel 2021-2027, destinate la maggior parte alle priorità “transizione verde”, “transizione digitale” e “competitività intelligente”. Il programma è articolato in sei Priorità principali, oltre a quelle indicate sono presenti “mobilità urbana sostenibile”, “Sardegna più sociale e inclusiva” e “sviluppo integrato urbano e territoriale”.
La dotazione del Fondo Sociale Europeo Plus, ripartita secondo quattro voci
A cui sono destinate il 31,20% delle risorse
A cui sono destinate il 23,52% delle risorse
A cui sono destinate il 25,92% delle risorse
A cui sono destinate il 15,36% delle risorse
Bisogni e visioni strategiche
I fondi di coesione permettono, in particolare in regioni come la Sardegna, concrete opportunità di sviluppo e rappresentano una delle principali fonti di finanziamento pubblico. Fino a oggi i fondi di coesione hanno avuto un obiettivo chiaro: superare le disuguaglianze territoriali. Alla luce delle ultime mosse della Commissione sembrerebbe che l’obiettivo stia mutando e che i fondi, in prospettiva, possano andare anche a Regioni già molto sviluppate economicamente, purché gli investimenti siano in linea con i nuovi obiettivi. Se così fosse sarebbe la fine delle politiche di coesione, per come le abbiamo conosciute.
Molti affermano – non a torto – che per come sono state programmate e attuate, le politiche di coesione non abbiano funzionato bene, soprattutto in alcuni Stati come l’Italia. Sono numerose le analisi e le esperienze che mostrano come tante risorse siano state programmate e spese senza partire da concreti bisogni o da visioni strategiche, ma con l’esigenza di giustificarli e collegarli ad obiettivi e capitoli di spesa che, nell’applicazione pratica, non trovavano poi aderenza alle reali necessità dei territori o non erano capaci di generare l’impatto sociale ed economico auspicato. Su questo anche il PNRR sta purtroppo dimostrando la sua parziale inefficacia, nonostante la sua enorme portata finanziaria.

In conclusione, sebbene le politiche di coesione abbiano necessità di una riforma che ne migliori l’efficacia, esse sono tuttavia cruciali per il futuro dei singoli territori e dell’Unione Europea nel suo insieme. In questo momento storico in cui si vogliono destinare importanti risorse alla difesa è bene ricordare che la sicurezza non deve riguardare solo armi e frontiere, ma dimensioni come la coesione sociale, la stabilità economica e la sicurezza energetica.
Sicurezza dovrebbe significare assenza di situazioni indesiderabili in un determinato contesto o sistema, non avere eserciti più forti; significa avere territori dove le persone hanno un lavoro, una casa, servizi di welfare, energia a prezzi accessibili, migliore qualità della vita, aria e acqua pulita. Una società che non riconosce che i problemi sociali ed economici strutturali sono le prime dimensioni della mancanza di sicurezza, è destinata a disgregarsi. Indebolire la politica di coesione è quindi un errore strategico che mina la sicurezza a lungo termine dell’Europa: il contrario, invece, dovrebbe essere la via, per un futuro più stabile e coeso.
Questo approfondimento fa parte della rubrica Maestrale a cura di Stefano Gregorini.








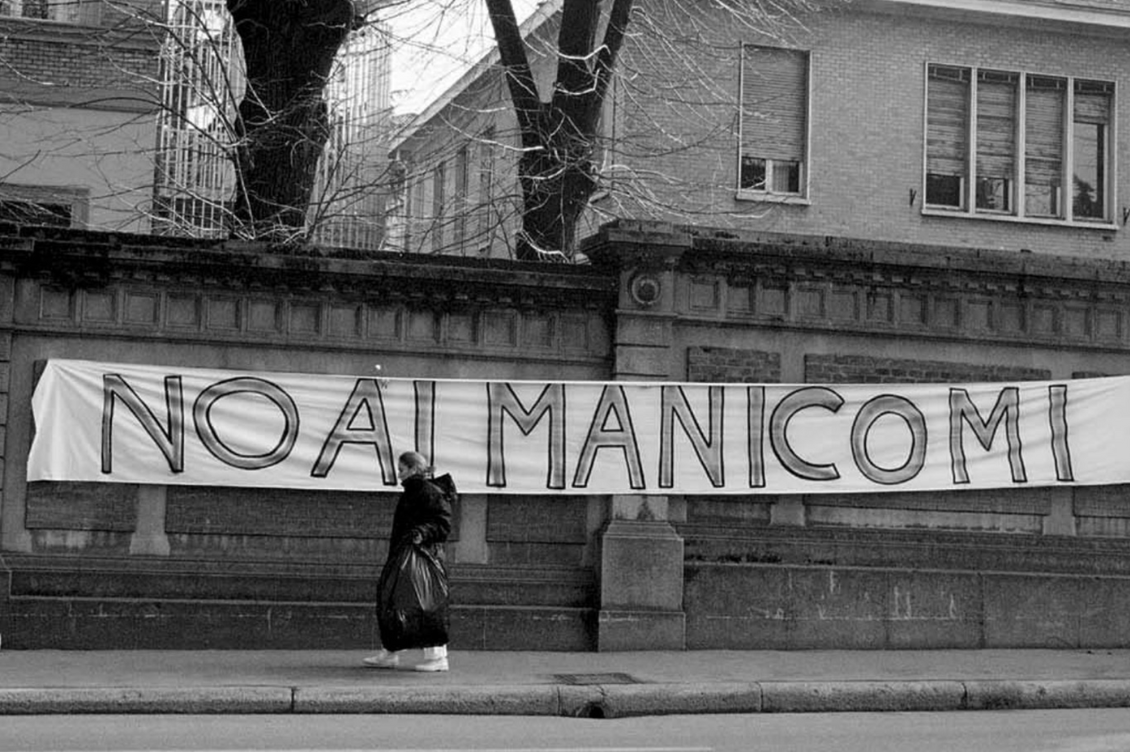





Commenta l'articolo
Per commentare gli articoli registrati a Italia che Cambia oppure accedi
RegistratiSei già registrato?
Accedi