Considerazioni sull’esito delle elezioni politiche
Le elezioni politiche hanno sancito una vittoria netta delle forze che propongono, in forme e modalità differenti, cambiamenti radicali. Si tratta di un fenomeno transnazionale, tipico di un momento di crisi profonda di un sistema socio-economico che si scontra con i limiti del Pianeta. Tuttavia anche le soluzioni più radicali rischiano di essere inefficaci o persino controproducenti se non tengono conto di determinati fattori. Ecco perché.
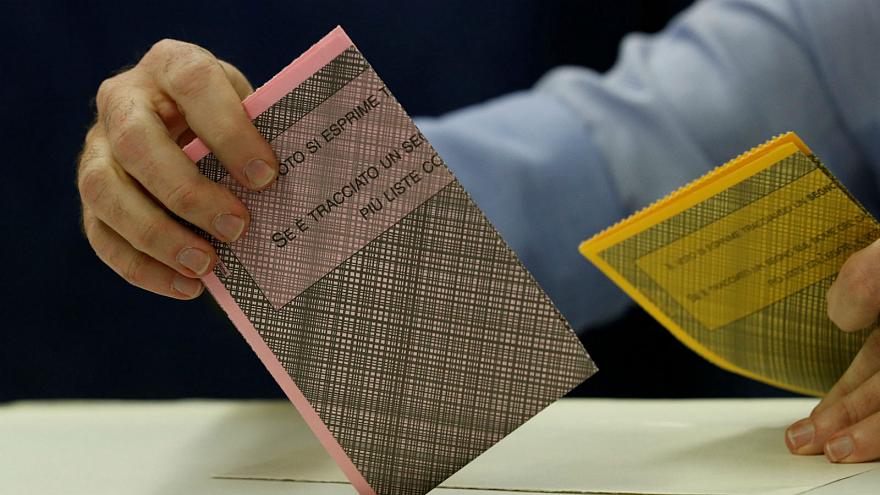
Alcune considerazioni, a caldo e in ordine sparso, sulle elezioni politiche. Proverò a scrivere questo articolo nella maniera il più possibile analitica ed oggettiva, senza lasciarmi tentare da partigianerie di vario tipo. Ergo farò incazzare un po’ tutti.
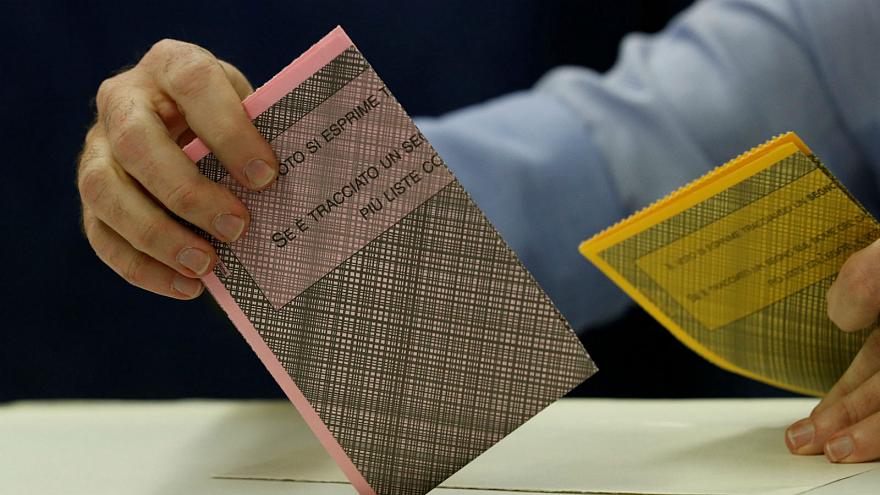 Hanno vinto le forze che propongono cambiamenti più radicali. Si tratta di due schieramenti, il Movimento 5 stelle e la Lega, che arrivano da percorsi e propongono soluzioni molto diverse fra loro: il primo è un movimento post-ideologico che rivendica una partecipazione attiva della cittadinanza all’azione politica, il secondo è un partito con tendenze xenofobe che è transitato da una linea secessionista ad una sovranista, ostile all’Europa e ai migranti. Hanno perso senza appello i partiti più legati all’establishment attuale, in primis Pd e Forza Italia.
Hanno vinto le forze che propongono cambiamenti più radicali. Si tratta di due schieramenti, il Movimento 5 stelle e la Lega, che arrivano da percorsi e propongono soluzioni molto diverse fra loro: il primo è un movimento post-ideologico che rivendica una partecipazione attiva della cittadinanza all’azione politica, il secondo è un partito con tendenze xenofobe che è transitato da una linea secessionista ad una sovranista, ostile all’Europa e ai migranti. Hanno perso senza appello i partiti più legati all’establishment attuale, in primis Pd e Forza Italia.
Chi promette di rivoluzionare il sistema, pur in forme e con obiettivi diversi, ha sconfitto chi punta a stabilizzarlo. C’è una fortissima esigenza di cambiamenti drastici, pur sgangherata, caotica e poco chiara per i più. Cercherò di fare chiarezza analizzando il contesto in cui nasce, le cause scatenanti e infine le possibili conseguenze.
Partiamo dall’osservare che questa tendenza che emerge chiaramente dalle nostre elezioni si può riscontrare anche in altre aree europee: Podemos in Spagna, Syriza in Grecia, l’Ukip in Inghilterra, il Front National in Francia, il Freedom party in Austria, Alternative for Germany in Germania sono tutte forze che sono andate creandosi una sempre più consistente base elettorale. È dunque evidente che i motivi non sono da ricondurre esclusivamente a vicende nazionali ma vanno iscritti nella complessa situazione globale contemporanea.

Viviamo un’epoca di crisi ricorrenti e cambiamenti rapidi e traumatici: per alcuni aspetti siamo nel bel mezzo di una tempesta perfetta, una crisi sistemica. L’indice di diseguaglianza sociale è ai massimi livelli nella storia dell’uomo, lo scacchiere geopolitico è oltremodo delicato, i cambiamenti climatici generati dalle emissioni antropiche climalteranti stanno per raggiungere il punto critico di non ritorno (secondo alcuni climatologi l’hanno già raggiunto), il crollo della biodiversità sta mettendo in seria difficoltà gli equilibri degli ecosistemi, l’acidificazione degli oceani (dovuta sempre alle emissioni di co2) mette rischio la vita marina, la spropositata produzione di rifiuti sta inquinando e contaminando la catena alimentare e così via.
Tutti questi problemi, e i molti altri che non ho citato per esigenze di spazio e cura della salute mentale dei lettori, non sono effetti separati e congiunturali, né gli errori di percorso di una struttura per il resto sana, ma i molteplici sintomi di un sistema completamente disfunzionale che ci sta portando dritti verso l’estinzione. A dirlo, purtroppo, non sono io ma sempre più team di scienziati che ormai dai primi anni Settanta lanciano allarmi perlopiù inascoltati.
Dunque, se il sistema è allo sbando e necessita di essere cambiato radicalmente, ben vengano le forze cosiddette antisistema, verrebbe da pensare. In realtà la questione non è così semplice: infatti se è evidente che un’azione politica coerente con il sistema difficilmente porterà a dei grossi cambiamenti, è altrettanto vero che esistono svariati fattori che tendono a rendere poco efficaci (alle volte persino controproducenti) le azioni delle forze cosiddette antisistemiche, a meno che non adottino strumenti e modalità particolari.
Provo a spiegarmi: di questa enorme crisi sistemica sono visibili ai più solamente i sintomi ed è dunque sui sintomi che si concentrano tutte le soluzioni proposte dalle forze politiche. Questo accade perché il sintomo è l’aspetto contingentale e facile da comunicare che preme all’elettorato. Partendo da questo presupposto risulta abbastanza semplice spiegare il fatto che, in un momento in cui i sintomi sono più gravi, tendono a prevalere le forze cosiddette antisistema, che riescono a far incetta di voti proponendo soluzioni allettanti per le sempre più consistenti masse rimaste ai margini di questo modello economico-sociale.

Tuttavia curare i sintomi, per quanto spesso necessario, non può essere una soluzione sufficiente, per almeno due ragioni. Innanzitutto si tendono a curare soltanto i sintomi più appetibili per l’elettorato. Ad esempio si possono proporre misure per ridurre la povertà per venire incontro ad una sempre più numerosa massa di nullatenenti, o promettere misure anti-immigrati per risolvere (si fa per dire) quella guerra fra poveri che si svolge ai margini di una società competitiva che viene letta come una guerra fra etnie o culture differenti, o incentivare la ripresa economica; ma chi ha il coraggio di imporre limiti ferrei sulla dispersione energetica delle abitazioni, sul trasporto individuale, sulla produzione di rifiuti pro-capite?
Chi ha la forza (anche elettorale) di far chiudere stabilimenti inquinanti, industrie pesanti, società petrolifere sapendo che così facendo si creeranno sacche di disoccupazione che non potranno essere istantaneamente riassorbite da nuove forme di occupazione sostenibile? Ci troviamo all’interno di un classico cortocircuito che si verifica quando proviamo a cambiare un sistema (quello attuale) con gli strumenti messi a disposizione dal sistema stesso (ad esempio la politica competitiva elettiva): semplicemente non funziona.
Questo sistema ci mette a disposizione un sacco di strumenti utili a fare le cose più svariate, tranne quelli che servono a cambiare il sistema stesso. Ecco spiegato lo scollamento fra le urgenze percepite e le urgenze reali e il fatto che pur in una situazione d’emergenza si continui a parlare dei soliti argomenti di sempre: tasse, immigrazione, Imu sulla prima casa. Che poi la vera domanda è: se ci estinguiamo, chi la paga l’Imu sulla prima casa?
Ma vi è un aspetto ancora più rischioso nell’adottare soluzioni sintomatiche in un momento di crisi sistemica: alcune volte possono portarci a risultati controproducenti. Faccio un esempio che riguarda la distribuzione della ricchezza nel mondo e che tira in ballo un’analisi che ho letto di recente e che mi ha molto colpito. Tale analisi mostra che, se magicamente riuscissimo ad azzerare la disparità economica fra Nord e Sud del mondo con uno schiocco di dita, condanneremmo la nostra specie ad un’estinzione quasi istantanea.
Infatti la concentrazione della ricchezza nelle mani di pochi, per quanto possa non piacerci, fa sì che anche le capacità di consumo siano concentrate nelle mani di pochi, che per quanto ricchissimi, non potranno mai consumare risorse come se quella stessa ricchezza fosse ripartita in parti uguali. Ne consegue che se ripartissimo equamente le ricchezze gli esseri umani consumerebbero le risorse del Pianeta con un ritmo di circa dieci volte quello attuale.
Con questo voglio dire che la disparità economiche sono giuste? Assolutamente no. Voglio soltanto affermare che se la affrontiamo come un sintomo slegato dal funzionamento del sistema nel suo complesso rischiamo di fare più danni che altro. E questo vale un po’ per tutte le soluzioni che la politica è solita proporre. Non è pensabile di affrontare il problema della povertà, dell’immigrazione, dell’ambiente, come se fossero argomenti slegati fra loro: sono tutti aspetti particolari di un sistema in cui merci e persone viaggiano come schegge impazzite da un lato all’altro del globo, in cui produzione, trasporto e consumo sono totalmente delocalizzate, in cui le tutto è separato, frazionato, incasellato e nessuno riesce ad avere una visione d’insieme.
Il punto, paradossale, è che in un sistema democratico elettivo nessuna forza politica, né pro-establishment, né antisistema, sembra avere gli strumenti per cambiare il sistema. Non è un caso che i paesi che stanno attuando le politiche più sostenibili nel mondo siano delle dittature più o meno mascherate. Mi riferisco ad esempio al Buthan, l’unico paese al mondo a impronta ambientale negativa, e alla Cina, che dopo che il leader Xi Jinping è praticamente assurto al rango di sovrano assoluto ha – prima fra le potenze mondiali – messo in discussione il dogma della crescita del Pil a favore di una rivoluzione verde.

Quindi, ricapitolando, è molto difficile che una forza politica riesca ad apportare cambiamenti sistemici significativi senza passare da una messa in discussione dei modelli di governance. E con questo non sto augurandomi l’avvento di una dittatura: esistono già oggi svariati esperimenti di sistemi alternativi su differenti scale di gran lunga più funzionali di questa democrazia rappresentativa nel tentare di porre rimedio a problematiche complesse. Alcuni di questi sistemi sono migliorativi del sistema attuale, come ad esempio la democrazia deliberativa; altri sono potrebbero persino essere sostitutivi, come la sociocrazia. E no, purtroppo la democrazia diretta non è un valido sistema alternativo (è un po’ lunga da trattare qui, ma mi riprometto di scriverne in un altro articolo).
Inoltre, non abbiamo idea delle conseguenze che un’azione politica volta al cambiamento potrà avere sulla società. Non sappiamo, ad esempio, a cosa porterà il reddito di cittadinanza o politiche economiche espansionistiche. Con questo non dico che siano sbagliate, ma semplicemente che è importante essere consapevoli di ciò che non sappiamo, quindi prevedere degli esperimenti a campione, dei cicli di feedback e apprendimento, e così via.
Infine, per concludere, sono pronto ad essere sorpreso e penso che dovremmo esserlo tutti. Se vogliamo iniziare a risolvere i problemi è necessario abbandonare le spoglie della competizione, del “vinco io – perdi tu”, ed aprirsi genuinamente agli altri. È necessario collaborare fra tutti e con tutti, perché la soluzione non arriverà da un’unica parte. Non possiamo più permetterci (in 7,5 miliardi di persone e con mezzi tecnici senza precedenti) di vivere in un sistema in cui si compete per l’accaparramento delle risorse del Pianeta. E l’unico modo di uscire da un sistema competitivo è smettere di competere.














Commenta l'articolo
Per commentare gli articoli registrati a Italia che Cambia oppure accedi
RegistratiSei già registrato?
Accedi