Figli di un Dio "artificiale": esistono limiti al dominio della tecnica?
Esiste un limite al desiderio di avere un figlio? Il ricorso alla tecnica – e in particolare alla fecondazione eterologa – può essere considerato lecito da un punto di vista meramente esistenziale? Quali implicazioni si svelano nella commistione “patologica” fra tecnica e vita?

Partiamo da un assunto: la tecnica non è sempre buona. Che non lo sia sempre, come è ovvio, non vuol dire che non lo sia mai. Quando non si eleva a fine dell’agire umano, ma la si considera per ciò che è (un semplice mezzo), la tecnica può essere utile: e ciò che è utile viene usato strumentalmente in vista di qualcosa di più grande. Il problema, però, è che oggi la tecnica si è fatta scopo e sovrasta il mondo intero, dominando anche chi ritiene di appartenere all’élite, e crede di avere il potere nelle sue mani e di poterne disporre a piacimento.
Nella sua complessità, la questione è maledettamente chiara: l’essere umano non usa più la tecnica ma viene da questa usato, sfiancato, sfinito. Tutto è ormai tecnico. La razionalità quotidiana è tecnica. I bisogni personali sono condizionati e dettati dall’apparato tecnico. E tecnica è ogni espressione sociale e politica.
Il 14 febbraio 2016 è uscito su il Manifesto un articolo di Paolo Ercolani, ampiamente condivisibile, in cui l’autore pone la questione del rapporto fra l’uomo, la tecnica e la natura. Ercolani sostiene che chi si getta fra le braccia della tecnica, considerandola un destino, rimuove dalla scena quotidiana il protagonista della riflessione e del pensiero: l’essere umano. Insomma: l’homo technicus e l’homo humanus si escludono a vicenda, sono ontologicamente incompatibili, sono fatti di carne e di sangue diversi e non possono abitare lo stesso spazio, perché parlano lingue inconciliabili che danno realtà a mondi fra loro lontani.
Il problema è che ormai da decenni l’occidente sembra rassegnato all’ineluttabilità del dominio tecnico. D’altronde, secondo la vulgata, l’uomo si è sempre servito della tecnica e sempre se ne servirà. Il che è certamente comprovato, come d’altra parte è altrettanto comprovato che da quando l’essere umano ha mosso i suoi primi passi nel mondo, non ha mai avuto a disposizione, come invece accade oggi, un apparato tecnico così potente e capace di creare davvero le condizioni per una non permanenza della vita sulla terra.
Si tratta di capire, allora, che dinanzi alla bomba atomica, alla costruzione di armi sempre più sofisticate o alla manipolazione genetica (solo per fare qualche esempio di tecnica distruttiva o potenzialmente pericolosa) non si può restare a guardare senza profferire parola. Perché ne va della sopravvivenza umana. Ne va della nostra storia e della storia della natura intera.E si tratta di capire pure che rimettere in discussione la tecnica è, ai nostri giorni, un passaggio fondamentale, se non ci si vuole ridurre a meri esecutori di una razionalità violenta e di potere. D’altronde, la violenza e il potere si sono sempre serviti della tecnica per incrementare la pressione dispotica sui dominati. Ma oggi, come si diceva, la tecnica nasconde in se stessa una straordinaria potenza distruttiva e disarticolante della realtà. Ciò sta a significare che a fronte di uno strumento estremo, se non ne mettiamo in discussione l’uso, concretizziamo e legittimiamo anche una violenza e un potere estremi.
E il potere che controlla da tempo i corpi e la morte, ha finito per mettere le mani pure sulla nascita. Ma un potere che dà la vita, un potere che decide in quale forme dare la vita è un potere che ha perso di vista il senso della misura e pretende di farsi natura o Dio (a seconda dei gusti).
Qui, sia chiaro, non si tratta di essere d’accordo sull’inseminazione artificiale a fasi alterne e magari di criticare il ricorso all’utero in affitto per le coppie omo, consentendolo invece alle etero. E non c’entra neppure la questione della paternità o della maternità mancante nel caso di adozioni in coppie omogenitoriali: in linea di massima credo che due omosessuali possano essere più bravi di me – eterosessuale – nella gestione e nell’educazione di un figlio. E ritengo giusto estendere i diritti civili alle coppie dello stesso sesso: ma non è questo il punto in questione. Perché qui si tratta invece di discutere del limite a cui dovremmo sottoporre la tecnica tenendo conto dell’ambito esistenziale, umano e spirituale (da non confondersi col religioso) entro cui ognuno di noi esiste e costituisce in ogni momento relazioni ontologiche col contesto. E bisogna allora capire dove sia possibile collocare un punto, un argine estremo all’uso indiscriminato della tecnica nella “produzione” della vita.
La situazione è così caotica che le fazioni avverse si contrappongono ripresentando però le medesime posture e gli stessi errori metodologici. Se ci soffermiamo sulla produzione della vita in laboratorio, ad esempio, mi pare che i fautori della nascita in provetta commettano un po’ lo stesso errore, ma al contrario, dei cattolici sul fine vita. Chi sostiene il diritto e la liceità dell’inseminazione artificiale (eterologa) – e interviene quindi con la tecnica alla nascita – è poi però magari favorevole alla legalizzazione dell’eutanasia: ovvero sostiene la giusta sospensione della tecnica nel fine vita.
I cattolici, invece, negano che si possa generare una vita in laboratorio, ma poi ritengono illegittima la sospensione di cure anche quando il malato ritiene di non voler vivere più attaccato a una macchina o seguendo un protocollo codificato. Che differenza c’è tra la creazione di una vita in laboratorio e un polmone d’acciaio che diventa una gabbia insopportabile? Sempre di tecnica si parla. È la vita che viene manipolata ed esautorata da un potere più grande, da uno strumento più efficace nel generare o nel mantenere in vita ciò che senza di esso non sarebbe mai nato o sarebbe morto prima.
Mi pare sia necessario quindi compiere ulteriori passi in avanti nella consapevolezza delle proprie azioni e dei limiti iscritti nella nostra natura (che non va divinizzata, certo, ma neppure oscurata del tutto). E intendiamoci: non si tratta di elaborare leggi o di formulare norme con cui limitare o impedire una serie di azioni. Ma è soltanto una questione di sentimenti e d’amore.
Insomma: su ciò che concerne l’inizio e la fine della vita credo che lo Stato faccia bene a non entrare, o ad entrarvi il meno possibile. Perché nel dare spazio alla vita e nel proteggerla dalla tecnica bisogna solo rintracciare la regola che abbiamo incistata nel cuore. La regola della nostra umanità che ci spinge a riflettere, ragionare, meditare sui limiti e sul desiderio di superarli. Ma non ogni desiderio (o si dovrebbe forse parlare di bisogno?) è legittimo. Non ogni superamento (annullamento?) dei limiti ha dignità spirituale. Anche di questo dobbiamo essere consapevoli per evitare di consegnarci mani e piedi al destino annichilente della tecnica, che tutto trasforma e travolge dal nulla verso il nulla.
Da ultimo, vorrei ricordare la lezione di Dante, sempre valida: “Io e’ compagni eravam vecchi e tardi / quando venimmo a quella foce stretta / dov’Ercule segnò li suoi riguardi / acciò che l’uom più oltre non si metta”. Il limite ci deve essere proprio perché si accenda il desiderio vitale di oltrepassarlo. Se non c’è, si annega in un mare di futili bisogni. L’impresa umana, invece, colma d’amore per l’umanità intera, si misura e prende dignità solo quando è di fronte a un’impossibilità e arriva a bruciarsi dopo una vita d’esperienza.







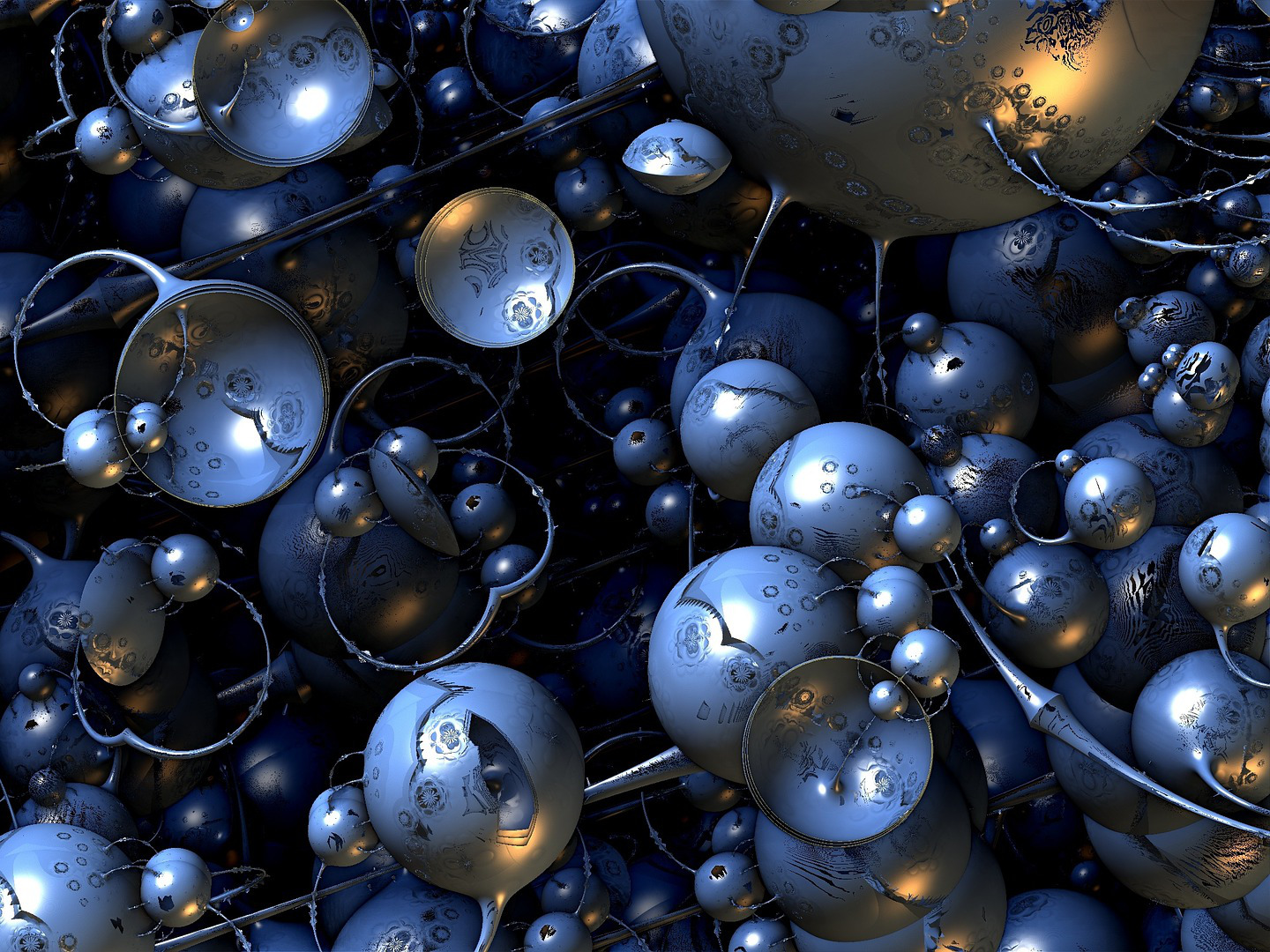







Commenta l'articolo
Per commentare gli articoli registrati a Italia che Cambia oppure accedi
RegistratiSei già registrato?
Accedi